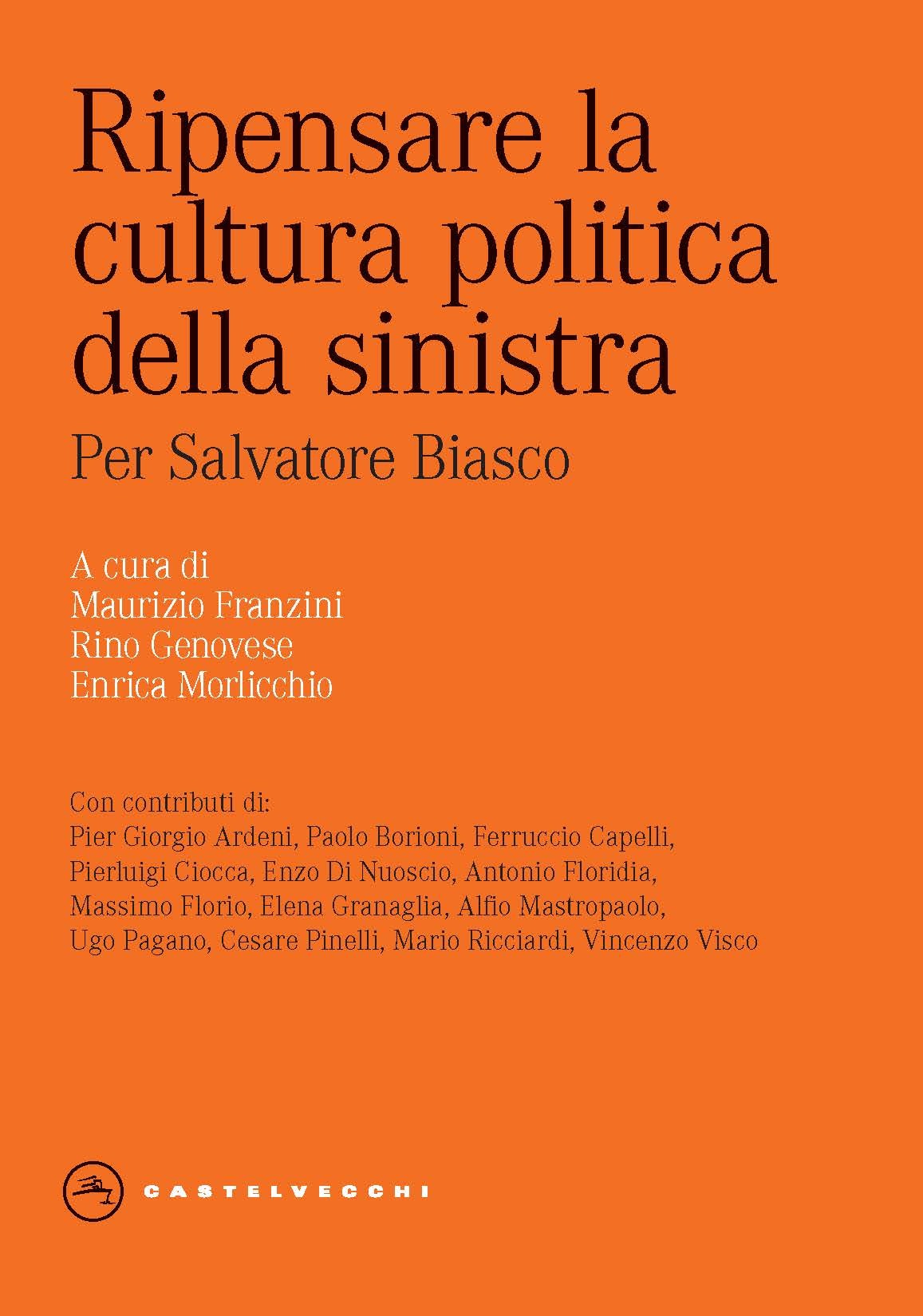Giornale politico della fondazione per la critica sociale


Giornale politico della fondazione per la critica sociale


Rino Genovese 794
Paolo Barbieri 755
Stefania Limiti 1168
Luca Lenzini 769
Rino Genovese 965
Alfonso Gianni 1540
Luca Baiada 2397
Agostino Petrillo 1090
Michele Mezza 822
Paolo Barbieri 956
Giorgio Graffi 1312
Rino Genovese 782
Rino Genovese 1275
Aldo Garzia 1004