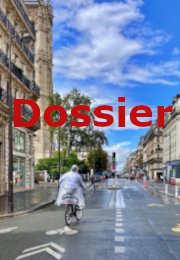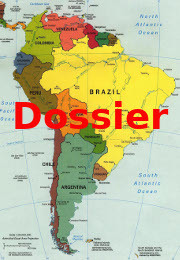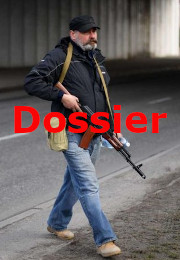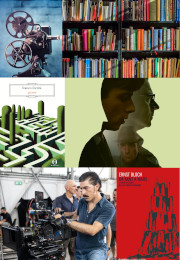La destra e l’irreversibilità del potere
Trump appare vincente. In pochi giorni le gaffe e l’imbarazzo per le sue contraddizioni si sono rovesciati in una serie di successi. La guerra all’Iran rimane incerta nell’esito militare, ma sicuramente non è stata una sconfitta per la Casa Bianca, che rafforza il suo sodalizio con Netanyahu senza pagare alcun prezzo politico. Certo, una parte dell’America ribolle. Ma l’opposizione sembra ancora lontana da quella pancia popolare che rimane saldamente legata al presidente sovranista.
Sulla scena internazionale si susseguono risultati che il tycoon può vendere come successi. La decisione di esentare la Silicon Valley dalla minimum tax – l’imposizione fiscale che doveva colpire i lauti profitti realizzati dalle imprese digitali – è un’amarissima beffa per l’Europa. Avevamo pensato una norma per ridurre l’accaparramento di risorse da parte dei monopoli digitali americani, e poi li abbiamo esentati da questa norma. Nemmeno le “sette sorelle” del petrolio – al tempo del loro massimo potere, negli anni Sessanta – avrebbero potuto concepire un tale privilegio. Siamo a una resa senza condizioni. Come i palestinesi e gli iraniani, sotto le bombe.
Serbia al bivio
Gli studenti serbi non demordono. Dopo le grandiose manifestazioni dello scorso inverno (vedi qui e qui), le più massicce degli ultimi trent’anni – si parla di trecentomila partecipanti –, i giovani hanno lanciato un nuovo monito alle massime istituzioni del Paese perché tolgano il disturbo. In un’intervista rilasciata al Sir (Servizio informazione religiosa, organo della Cei), l’analista dei Balcani, Nikolay Krastev, è molto chiaro: “La situazione in Serbia si sta radicalizzando perché il 28 giugno, a Belgrado, c’è stata una protesta di massa degli studenti che chiedono elezioni anticipate previste in realtà fra due anni, mentre il presidente Alexandar Vučić, l’uomo forte di Belgrado in carica dal 2017 quando divenne presidente della Repubblica (dopo essere stato primo ministro dal 2014 al 2017, ndr), non pensa minimamente di cedere alle loro richieste”.
Dalla musica agli armamenti
Consulenti e intermediari finanziari del settore private equity si sono riuniti, nella settimana del 6 giugno a Berlino, in occasione della conferenza annuale SuperReturn, per discutere dei futuri orientamenti d’investimento. Tra i temi dominanti, è emersa la proposta di canalizzare fondi verso l’industria della difesa europea, con l’obiettivo di trarre profitto dall’aumento della spesa militare da parte dei governi e, al contempo, rilanciare un mercato in difficoltà.
Tra Congo e Ruanda la “pax americana”
Il 27 giugno, i ministri degli Esteri della Repubblica democratica del Congo e del Ruanda hanno firmato a Washington un accordo di pace che dovrebbe mettere fine a un conflitto (vedi qui) ormai trentennale nel Kivu, la regione nordorientale del Congo, che ha fatto decine di migliaia di vittime. Trump attende a Washington i due presidenti– Felix Tshisekedi del Congo e Paul Kagame del Ruanda – per un vertice interstatale entro la fine di luglio.