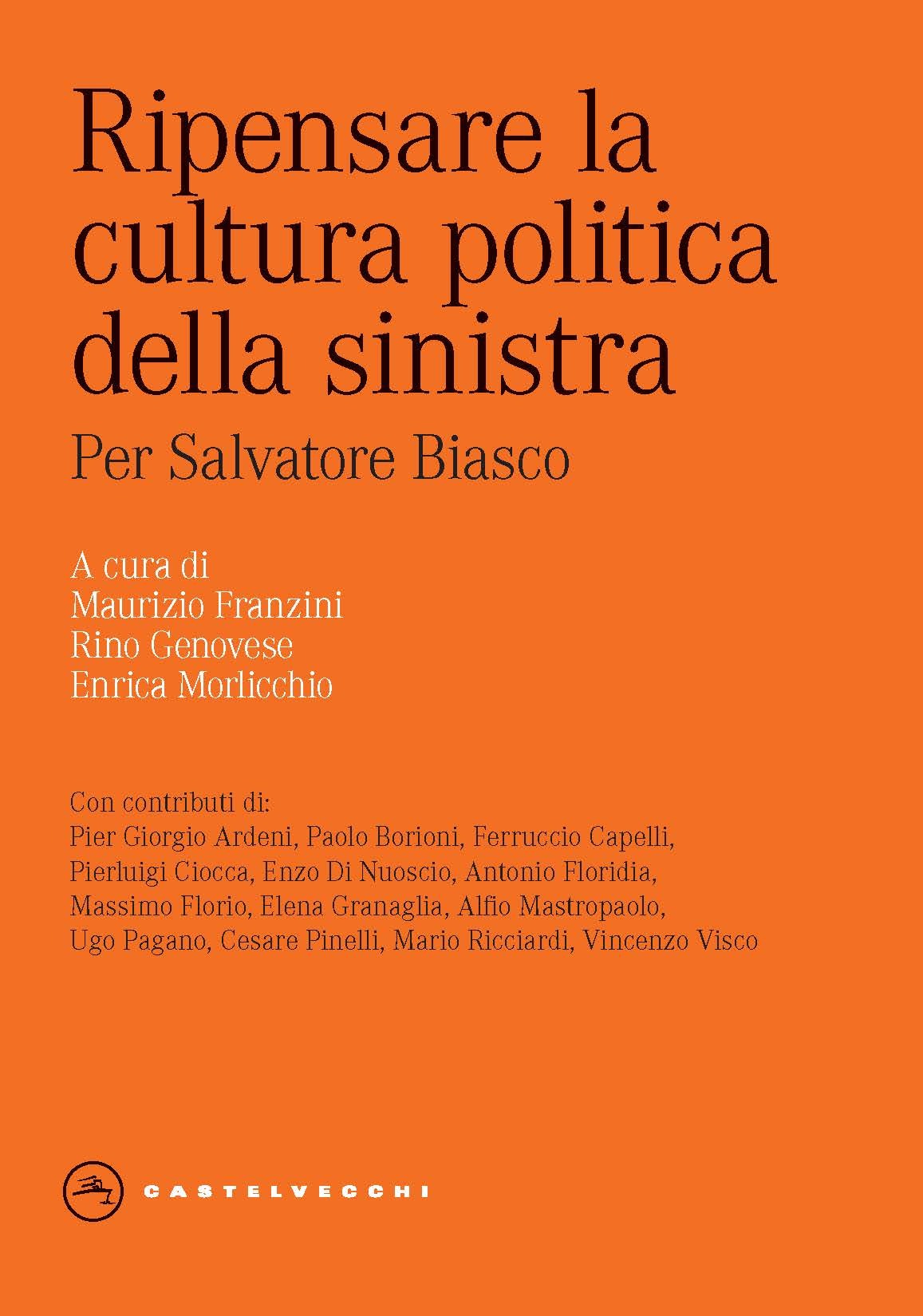Con il suo ultimo libro, Achille Occhetto (Perché non basta dirsi democratici. Ecosocialismo e giustizia sociale, Guerini e Associati, 2022, pp. 200, 18,50 euro) ha voluto lasciare il suo testamento politico, come scrive nelle righe finali. Testamento è forse parola pretenziosa per un libro che, tutto sommato, elenca per il socialismo del presente e del futuro un insieme di temi, che l’autore definisce una filosofia sociale. Una definizione eccessiva, vista la frammentarietà e il solo accenno ai problemi e alle soluzioni. Va rispettato comunque il suo sforzo: per questo, proveremo a delineare i punti di forza e ciò che, al contrario, non va nella riflessione dell’autore.
Prima di arrivare al fulcro del testo, e cioè all’idea di ecosocialismo, e quindi di connessione tra critica del capitalismo e lotta per la salvezza del pianeta, rileviamo che Occhetto, ancora una volta, non nasconde il bisogno di dover giustificare lo scioglimento del Pci, rivendicando la giustezza di quella scelta. E così le prime cento pagine – metà del libro – sono dedicate a una sorta di dialogo con Antonio Labriola, per affermare il socialismo come sforzo continuo di lotta e non come ideologia perfettista, come regime valido una volta per tutte e costruito da una classe sociale dotata di una dottrina ferrea e inesorabile. Questa parte è sorprendente, e si spiega solo con il risentimento di Occhetto, con la sua volontà di voler ribadire la validità della svolta della Bolognina, nel 1989. Il socialismo-comunismo, come prassi che sposta in avanti gli equilibri della giustizia sociale e della liberazione umana giorno per giorno, immettendo elementi di socialismo nella democrazia italiana, ha infatti caratterizzato proprio la storia del Pci lungo una linea che da Gramsci arriva a Berlinguer, passando per Togliatti (per non parlare del comunismo come orizzonte di Ingrao).
Venendo al fulcro della riflessione politica per un nuovo socialismo – o, per meglio dire, ecosocialismo –, l’assunto fondamentale di Occhetto è il seguente: la vecchia contraddizione tra capitale e lavoro si allarga a “contraddizione tra l’energia complessiva del lavoro materiale e intellettuale incorporato nella scienza e nella tecnologia e l’appropriazione privatista e incontrollata dei frutti dell’intelligenza sociale complessiva”. Non si tratta solo di superare la separazione del frutto del proprio lavoro da parte del lavoratore, ma anche di superare la “separazione dell’insieme dell’umanità dai frutti della scienza”. Per Occhetto, il socialismo si configura allora come socializzazione dell’intelligenza scientifica, e del suo patrimonio sedimentato nel tempo, che, a sua volta, sarebbe la base del “processo di liberazione umana da tutti i vincoli del dominio e della subordinazione”.
In questo assunto sta forse la cifra del libro con tutta la sua problematica contraddizione. Da un lato, infatti, l’autore pare propendere per l’interpretazione del capitalismo come sistema in cui non è il tempo di lavoro a generare la crescita, quanto il lavoro vivo e sociale, di tipo soprattutto scientifico. Si tratta di un capitalismo che la socialdemocrazia non può più interpretare e contrastare adeguatamente, perché quel lavoro non è necessariamente antagonistico ed è incorporato nel capitale, si esprime in esso, ha bisogno di esso e delle sue grandi concentrazioni produttive. Dall’altro, egli ritiene che quella enorme massa di lavoro vivo, proprio in quanto lavoro sociale scientifico, possa liberarsi dal capitale e, così facendo, liberare l’intera umanità, salvando il pianeta dal privatismo capitalistico. Occhetto mostra così quali possano essere i soggetti capaci di imporre al capitalismo politiche in grado di rendere l’immensa ricchezza prodotta dal capitale un fattore di liberazione universale, che significhi anche salvaguardia dell’ambiente.
Dove sta dunque la contraddizione dell’assunto di partenza – e allo stesso tempo finale – di Occhetto? Ebbene, nel fatto che quel lavoro sociale scientifico è incorporato a tal punto nel capitale – anche se non necessariamente aderente alle sue finalità – che difficilmente può mettervisi contro, opporgli un antagonismo che lo costringa a perdere via via il suo carattere privatistico. A nostro avviso, tale contraddizione non è necessariamente un problema, e ci pare anzi feconda, ma dovrebbe essere sondata e approfondita con un elemento di riflessione che nel testo non è presente. Ci riferiamo al fatto che il problema del capitalismo attuale non è solo il suo sottrarsi alla socializzazione, alle necessità del bene comune. La logica del capitale è quella del dominio, una logica che pervade l’immaginario di uomini e donne nella nostra postmodernità. Per essa, gli esseri umani si pensano come viventi che non devono fare altro che consumare e divertirsi in un mondo che è a portata di mano come un insieme di cose da prendere e di cui godere. L’umano del nostro tempo non si concepisce come essere ontologicamente problematico, in quanto non predeterminato da un codice normativo o biologico, e nell’illimitatezza del dominio sulla natura cerca, in una sorta di cattiva infinità, di sopire le domande di quella problematicità. Ci si può allora chiedere se la socializzazione delle conoscenze scientifiche possa portare a una vera liberazione umana, a sottrarsi al dominio dell’umanità per affrontare davvero il limite insito nella fragilità ontologica dell’essere umano, per la quale la signoria sulla natura e il consumo illimitato in realtà non bastano a risolvere quella stessa fragilità.
Insomma, è vero che la socializzazione delle conoscenze scientifiche e l’uscita dal privatismo capitalistico potrebbe liberare l’umanità – se però l’umanità stessa decidesse di liberarsi, di uscire dal dominio e dall’illimitatezza dei consumi come ragione di vita. E però è altrettanto vero che quella decisione non è la conseguenza di una socializzazione e di una democratizzazione della scienza e delle sue conoscenze. Ci si può chiedere, infatti: si ha vera democrazia nel momento in cui tutti possono avere alti livelli di istruzione e condizioni dignitose di vita o nel processo in cui si istituiscono socialmente i valori dell’istruzione per tutti e della redistribuzione delle risorse? E il pianeta in quale momento si salva? Quando tutti potranno accedere all’istruzione e avere una casa e un lavoro sicuro, o nel momento in cui si decide di uscire dalla logica del dominio per accettare il limite della condizione umana e, quindi, non pensare più allo sfruttamento illimitato della natura?
Il circolo è evidentemente vizioso e perfino tragico, nel senso che non ha soluzione. Da un lato, si sceglie democraticamente quando si è nelle condizioni di farlo in termini di consapevolezza e condizioni materiali adeguate – e quindi di istruzione e di benessere –, dall’altro, la democrazia è il processo dell’istituzione sociale di quegli stessi valori dell’istruzione e del benessere per tutti. L’essere umano non può uscire da questo circolo tragico, e chi si appella al socialismo o all’ecosocialismo deve provarsi a stare al suo interno, cercando di promuovere la riflessione filosofica sulla sua indeterminazione ontologica, lavorando al tempo stesso per garantire una vita dignitosa e alti livelli di istruzione a tutti.
La riflessione di Occhetto muove da un assunto fondamentale, che può essere una buona base di partenza per entrare nella complessità tragica dell’opposizione al capitalismo, a partire dall’inadeguatezza della socialdemocrazia; ma sembra non entrare fino in fondo in questa complessità: un ottimismo per la liberazione, grazie alla socializzazione della scienza, che non scorge il tema del dominio e della costituzione ontologica dell’umano, è forse ciò che lo distoglie dalla necessaria profondità della riflessione.