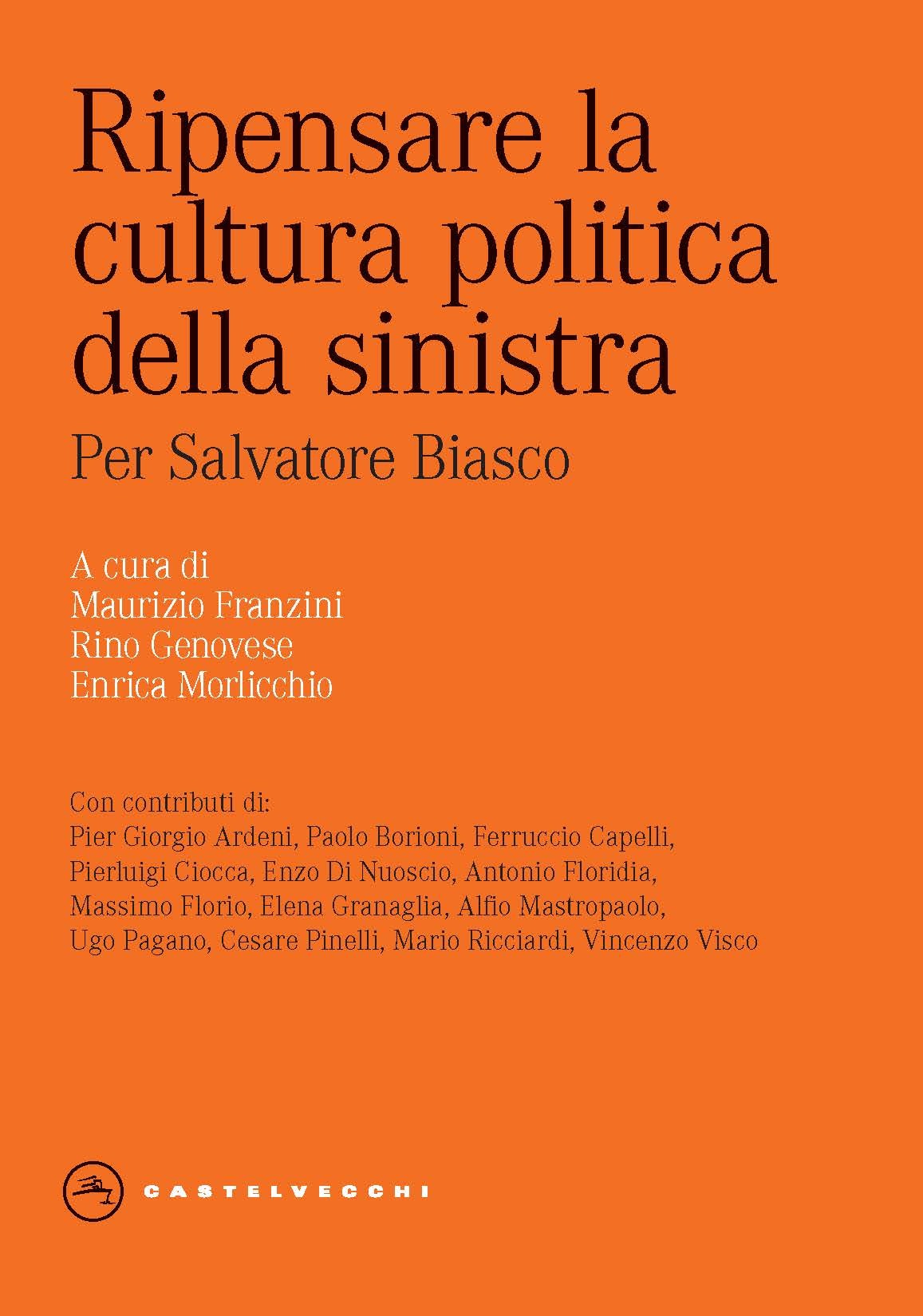Scriveva Albert Einstein nel 1934: “Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”. Quello che stiamo vivendo è un momento particolare della storia: l’essere umano si trova di fronte a situazioni e problemi che non è in grado di gestire completamente; i cambiamenti non solo sono tanti e di ampio rilievo, ma si susseguono anche a un ritmo frenetico, accavallandosi spesso gli uni agli altri. Quella di oggi è una società che, come dice Edgar Morin, sembra viaggiare spinta da un quadrimotore spaziale (scienza, tecnica, industria, profitto) fuori controllo, che trascina impetuosamente il mondo in un divenire cieco.
È una società problematica sotto il profilo dell’educazione e della formazione delle nuove generazioni. Sentiamo dire in continuazione che gli studenti sono stressati, non ce la fanno più. I giovani, se vogliamo generalizzare, oggi non stanno bene, come dimostra la tragica vicenda del sedicenne di Abbiategrasso. Il fatto accaduto è un fatto individuale e non sociale, e di fronte a un episodio di questo genere – raro comunque in Italia – non si possono scomodare i grandi sistemi. Anche perché i grandi sistemi non offrono una soluzione rapida e immediata. Il ragazzo del milanese ha avuto un sacco di problemi, non affrontati seriamente da specialisti, che tantomeno la scuola è riuscita a gestire, perché non è previsto che un insegnante possa essere psicologo o psichiatra.
Ma non imputiamo tutto il malessere dei giovani al distanziamento sociale imposto dalla pandemia. Sarebbe riduttivo e creerebbe un deterrente che paralizza, creando un binomio pericoloso. Il disagio nasce dalla totale vacuità in cui crescono i ragazzi, c’è un problema di educazione alla base del disagio, e le cause sono complesse e profonde.
Un primo elemento è il collasso educativo della famiglia e della scuola, avvenuto con il progressivo passaggio dalla società della disciplina, che si regolava su ciò che era permesso e ciò che era proibito, alla società dell’efficienza e della performance spinta, spesso misurata dal numero dei like e dei follower a cui viene affidata la propria identità. Spesso accompagnata da un senso di insufficienza per ciò che si vorrebbe essere e non si riesce a essere a partire dalle attese altrui, dalle quali ciascuno misura il valore di sé stesso. I ragazzi oggi oscillano tra mancanza di lavoro e richiesta di prestazioni sempre più alte. Schiacciati dal senso di inadeguatezza. Iperconnessi eppure soli.
Tutto questo genera il disagio. L’identità non la possediamo per il fatto che siamo nati, ma è un dono sociale, è il risultato del riconoscimento o del misconoscimento che riceviamo dagli altri. Anche l’assenza del desiderio ha la sua responsabilità. Le immediate soddisfazioni dei genitori per le richieste dei figli hanno come effetto l’estinzione del desiderio, perché il desiderio è mancanza. Non si desidera quello che si ha, ma quello che non si ha. E in un clima di abbondanza e di gratificazioni, il desidero si spegne. La ragione va cercata nel difetto della trasmissione del desiderio in una civiltà come la nostra, che genera tanto godimento, tanto divertimento, ma sembra avere perso contatto con la vocazione profonda del desiderare.
Un altro grande problema è l’eccessivo individualismo: l’io della persona pensa di poter fare a meno dei tu che incontra dalla sua nascita; in tal modo sono state “erose” le fondamenta dell’educazione. Dall’altro lato, sono venute meno le consapevolezze e le certezze dei genitori e degli educatori; siamo nel tempo delle relazioni negoziabili: ovvero non è più chiaro cosa debba fare l’adulto che vive una sorta di sudditanza verso le generazioni giovani. Si avverte la mancanza di una relazione educativa generante.
Poi c’è la scuola italiana che spesso abbandona l’educazione per l’istruzione, veicolando esclusivamente contenuti culturali e scientifici. L’educazione consiste nel prendersi cura della condizione emotiva degli studenti, perché, come dice Platone, “la mente non si apre se prima non si è aperto il cuore”. E quando dico “cuore” penso a quel passaggio all’emozione. Ma per accorgersi dei percorsi emotivi di questi adolescenti, occorre stabilire con loro una relazione empatica, leggere cosa passa nella mente degli studenti a scuola, dei figli a casa, che ogni giorno insegnanti e genitori hanno di fronte. Questo richiede tempo, calma, lentezza, interesse e attenzione, tutte caratteristiche che sembrano essere fuoriuscite definitivamente dalle relazioni educative.
Poiché l’educazione è prima di tutto una relazione interpersonale, risulta fondamentale la conoscenza dell’altro, delle sue caratteristiche, del suo linguaggio, prima di avviare qualunque progetto. Nei contesti educativi è assolutamente opportuno curare, riflettere, ristrutturare e rinforzare qualitativamente le relazioni che, alla base di ogni processo di istruzione e formazione, permettono, anche grazie a uno scambio emotivo/affettivo, di conoscersi, riconoscersi, comprendersi e trasformarsi.
Occorre oggi ingaggiare una sorta di sfida educativa nei confronti del clima culturale prevalente. La crisi può essere un’opportunità: essa ci riporta a riconsiderare il valore e il senso di un atteggiamento di responsabilità, di disponibilità e di impegno per affrontare un compito che nessuno può oggi affrontare da solo. Dice Hannah Arendt: “Una crisi ci costringe a tornare alle domande; esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto; e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti, ossia pregiudizi, aggravando così la crisi e per di più rinunciando a vivere quell’esperienza della realtà, a utilizzare quell’occasione per riflettere, che la crisi stessa costituisce”.
Si guarisce quando si ritrova la propria vocazione. L’incontro con la nostra verità più profonda è l’occasione di una trasformazione. Il destino è questo impasto tra una provenienza che non governiamo e un avvenire che possiamo rendere possibile.