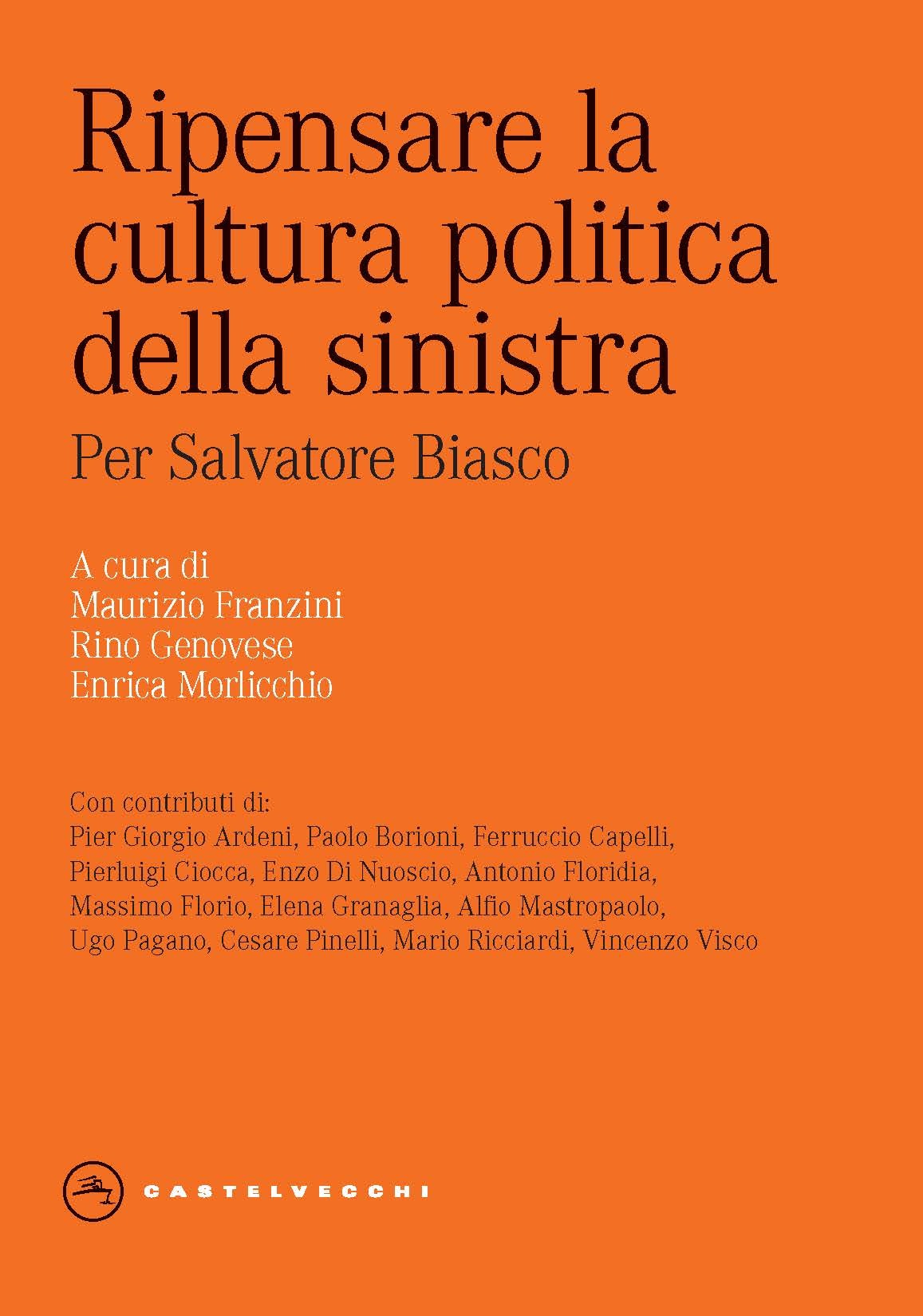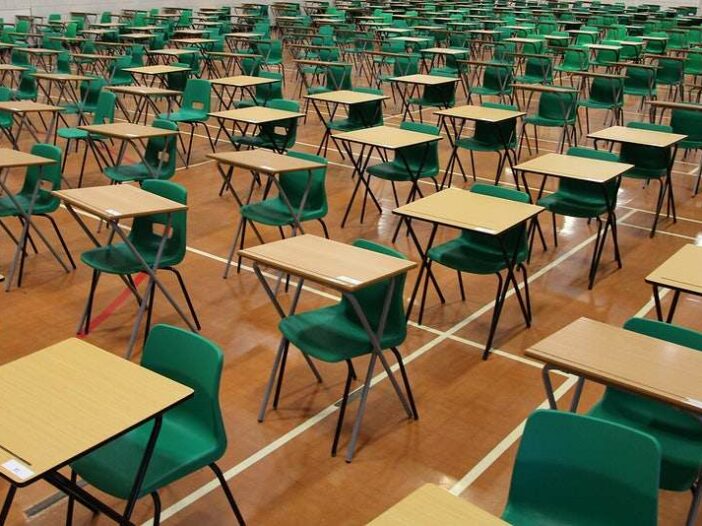
Cosa è successo in questo passaggio di tempo e di consegne? È successo che abbiamo rovesciato un paradigma molto semplice: quello scolastico. Volevamo cambiare il mondo, e in effetti è cambiato: non è più un mondo in cui la scuola tenta di insegnare a vivere. Qualcosa deve essere accaduto se gli imprenditori scrivono lettere aperte alle famiglie degli studenti delle medie ricordando loro che assumono operai e tecnici, mentre i percorsi di studio che un giovane potrebbe preferire spesso non sfociano in un’occupazione sicura. Tanti anni fa, in Toscana come in altre regioni d’Italia, i genitori erano operai o contadini, si spezzavano la schiena pur di fare studiare i figli. Volevano che stessero meglio di loro: nel portafogli, ma anche nella testa e nel cuore. Non è questione di preferire il lavoro intellettuale a quello manuale, entrambi nobilissimi. Solo di ricordare che la scuola non è nata per formare dei lavoratori, ma degli esseri umani.
Immaturità, superficialità, impreparazione, improvvisazione. La classe dirigente che si è proposta alla guida del Paese negli ultimi tempi rischia di essere ricordata come approssimativa, superficiale, sempre a caccia di scorciatoie, di una battuta brillante che supplisca alla fatica di farsi un’idea approfondita su un problema. Come il compagno di scuola che non studiava e pensava di risolvere facendo lo spiritoso, o esercitando il suo carisma quando veniva chiamato alla cattedra. Quello che non aveva ripassato la calata dei barbari e provava a protestare contro l’imperialismo culturale dei Romani, mutuando termini orecchiati nelle assemblee studentesche. Quello che sosteneva sempre che il problema era un altro, anche in matematica, quando il problema era innegabilmente quello scritto sulla lavagna.
I giovani leoni delle nostre aule parlamentari forse non se ne accorgono nemmeno, ma hanno fatto propria la bipartizione imposta nel ventennio berlusconiano tra simpatici da una parte e competenti, però noiosi, dall’altra. Intimoriti dall’idea di stare dalla parte dei secchioni, giocano tutto sulla rapidità della battuta. Mimano la velocità di analisi, ma si esercitano in una continua semplificazione che li porta a perdere di vista il problema.
Il tempo. È questo il grande paradosso dell’uomo contemporaneo: andare veloce, per non andare da nessuna parte. È la folle velocità, di cui è impregnata la nostra vita, la vera malattia del Ventunesimo secolo. Identità dentro vite rigide, in cui sono banditi l’errore, l’incertezza, la debolezza, dove non sono tollerate le crisi, le pause, le riflessioni. La corsa si accompagna all’inconsistenza, la competitività trionfa sui social, la vanagloria il valore massimo cui immolarsi.
La preparazione, l’impegno hanno lasciato il posto alla semplificazione. Ma la semplificazione è un inganno. La capacità di sintesi è una grande qualità, a scuola come in politica. Ma il riassunto non cancella la realtà dei fatti, la condensa al fine di trasmetterla, o di tenerla a mente. Un riassunto ben fatto non perde di vista le sfumature, anzi le mette in evidenza. Altrimenti non è un riassunto, si chiama censura o rimozione, se i vari aspetti li hai capiti. Impreparazione, se non li hai capiti. Per cogliere le sfumature, sono necessari tanti vocaboli. Un vocabolario limitato rende difficile articolare i concetti, palleggiarli nella mente e farli volare, esponendoli. Se non trovi le parole, e sei interrogato, prendi quattro. Se non trovi le parole, e sei al potere, puoi semplicemente abolirle.
Questo fa paura. Fa paura l’uso povero delle parole, la semplificazione estrema del linguaggio, che corrisponde a una semplificazione estrema dei concetti. Chi guida un Paese di questi tempi deve affrontare sfide epocali, come le migrazioni, le guerre, il terrorismo, le nuove povertà. Sfide che non hanno niente di semplice e nemmeno di semplificabile. Un politico che neghi la complessità, perché non ha le parole per spiegarla, come potrà affrontarla? Decidendo di cancellare qualche termine dal vocabolario? Il populista semplifica all’estremo, riduce a due: chi sta con lui (il popolo) e chi sta contro di lui (il nemico del popolo). Inutile dire che chi invoca la complessità è arruolato d’ufficio nelle file dei nemici del popolo. Perché “la gente non capisce”.
Ma uno dei punti fermi del mio lavoro di insegnante è che, se gli studenti non mi capiscono, la colpa è mia, perché non sono stata chiara. Credo che questo mi accomuni a chiunque, per lavoro, parli a una molteplicità di persone. Certo, se da una parte e dall’altra ci sono persone che hanno potuto frequentare con profitto ottime scuole, le possibilità di comprendere e di farsi comprendere aumentano. Se invece la scuola la mandiamo allo sfascio, non solo non riusciremo ad afferrare la complessità, ma anche con la semplicità avremo qualche problema. Non è che il pensiero non sia democratico: lo è. Il problema nasce quando pensiamo che la democrazia sia il diritto di non sapere. Per tutti questi motivi, la svalutazione della scuola e il tracollo della politica vanno di pari passo.