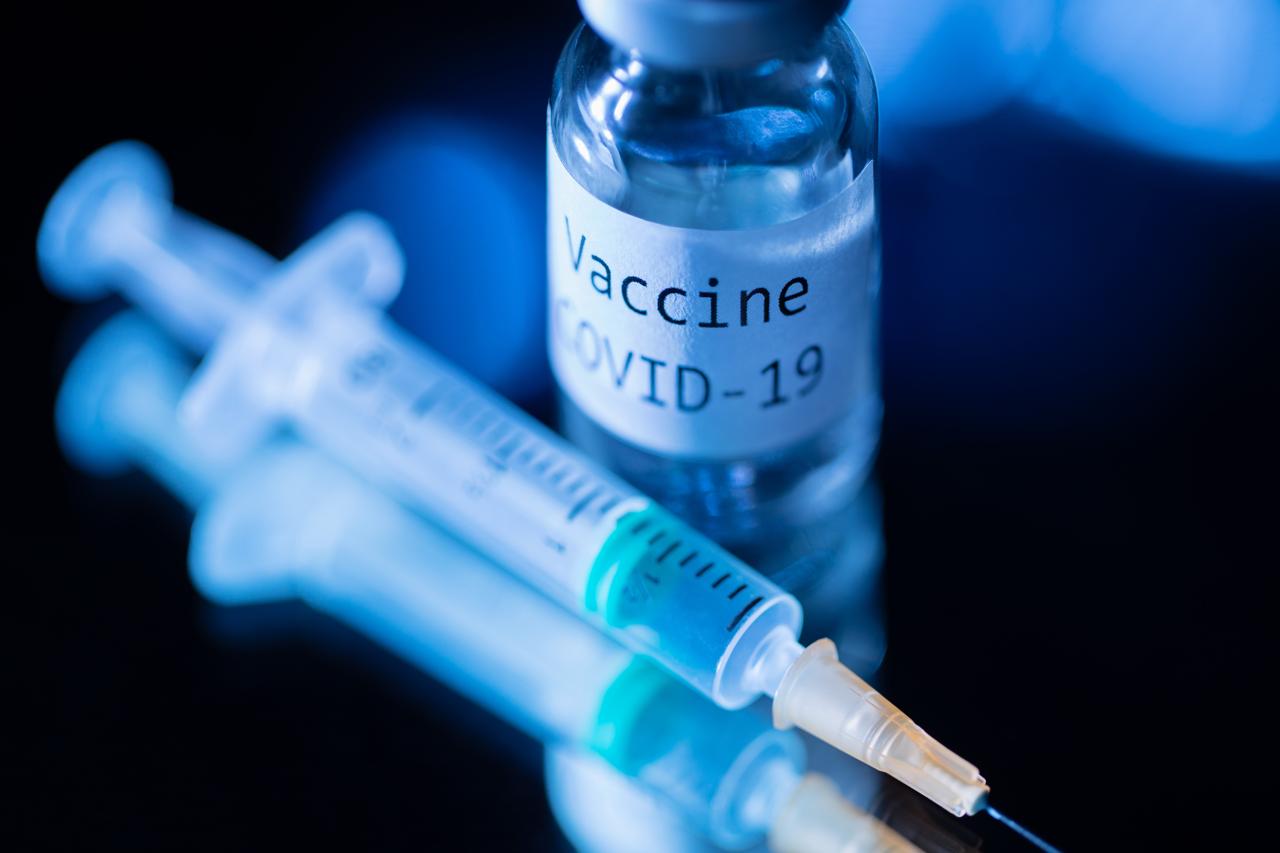
“Dobbiamo essere noi a chiedere al governo di procedere a un intervento legislativo chiaro che sancisca l’obbligo vaccinale per tutti e tutte”: così Alessandro Genovesi, il giovane segretario generale della Fillea, la federazione dei lavoratori delle costruzioni edili della Cgil, in un suo commento dello scorso 17 agosto su “Il diario del lavoro”, che potrebbe aver aperto una lunga stagione congressuale della principale confederazione sindacale del paese.
Il tema – che sta diventando discriminante non solo per la guida politica dell’organizzazione, ma per la sua stessa identità e riconoscibilità sociale – riguarda proprio il nodo delle vaccinazioni. Attraverso la questione della strategia di immunizzazione, forse per la prima volta con piena evidenza, è sbucata nella sede centrale della Cgil in corso Italia la talpa della metamorfosi della base sociale del sindacato, ovvero il quesito circa una sua diversa collocazione a cui il gruppo dirigente sta cercando una risposta. È una talpa che scava da tempo attorno alle radici dell’insediamento sociale dei sindacati confederali, spostando il peso ideologico e di domanda politica del mondo del lavoro dal campo riformatore e progressista a quello sovranista. Da almeno tre decenni, diciamo dal fatidico 1989, il mondo del lavoro si trova a mischiare i suoi consensi con quelli di una destra sociale e sovranista che ha preso in ostaggio proprio la base sociale sindacale, minacciata dalla svalutazione del lavoro da parte delle élite e dalla concorrenza globale soprattutto cinese.
I numeri ci dicono che convive ormai stabilmente nelle file sindacali una presenza massiccia di iscritti di voto leghista, se non a volte apertamente di destra, con una militanza più intransigente sul luogo di lavoro. Cose grosse, come si vede, di cui la pandemia è acceleratore e lente d’ingrandimento.
L’oggetto del contendere riguarda le forme e il senso della vaccinazione sul posto di lavoro: una semplice procedura che garantisca agli imprenditori la continuità della produzione, che non verrebbe insidiata dai rischi di focolai infettivi grazie appunto ai vaccini? O piuttosto una forte politica di valorizzazione dello spazio pubblico che, attraverso la volontà di assicurare la sicurezza dei cittadini, ponga il tema del contrasto alla pandemia come azione collettiva e sociale assicurata dallo Stato democratico? All’interno di questa opposizione si gioca l’identità sociale sia del sindacato sia del movimento del lavoro nel suo insieme, che deve trovare una collocazione autonoma e propositiva in questo snodo storico.
Come abbiamo scritto con Andrea Crisanti in Caccia al Virus (Donzelli), non ci troviamo in una crisi momentanea, ma in una transizione che ci sta accompagnando verso un mondo del tutto inedito, in cui le relazioni sociali si stanno riclassificando, mutando le stesse istituzioni politiche. E il motore del processo di trasformazione è dato dalla natura e legittimità del potere: guidato da una bussola pubblica o solo dalla convergenza di interessi individuali? Testimonial di questo scontro sono proprio i vaccini.
I due punti di vista separano in tutto il mondo la destra e la sinistra. A volte attraversano i due campi anche trasversalmente, ma poi, quando si deve arrivare allo snodo decisionale, la destra diventa libertaria e liberista, perché individualista e privatista, mentre la sinistra si trova a difendere l’idea della sanità come welfare universale e collettivo.
Ci troviamo dinanzi a un’apparente inversione dei ruoli che potremmo sintetizzare come uno scambio di prigionieri fra i due campi ideologici: la destra si trova oggi a brandire Michel Foucault, le sue lezioni sul nesso di potere tra medicina e Stato, date però quando era il movimento anticapitalista a guidare l’assalto al cielo, con la sinistra abbracciata a Carl Schmitt, ferma in una difesa passiva e silenziosa dello Stato come simulacro di un destino collettivo. Un giro di valzer che premia comunque solo la destra che – dopo aver perso la fase dell’emergenza sanitaria, durante la quale i suoi campioni hanno fatto disastri – si trova a essere vincente nella fase successiva della ricomposizione economica e sociale, capeggiando la rancorosa riscossa dei ceti subalterni rispetto alle élite privilegiate e agli ultimi assistiti. Come spiega Donatella Di Cesare nel suo saggio Virus sovrano (Bollati Boringhieri), stiamo entrando nella società del “noli me tangere” in cui il cittadino vede nel suo prossimo il nemico, o, al meglio, il competitore da cui prendere le distanze per vincere: un modello sociale entro cui lo Stato appare come un intralcio ostile persino quando distribuisce risorse.
In questo scontro la collocazione del sindacato, e della Cgil in particolare, non è apparsa né certa né tanto meno scontata. Con vari interventi a cavallo di luglio e agosto, Maurizio Landini ha introdotto, nel lessico famigliare della confederazione di Giuseppe Di Vittorio e Luciano Lama, il concetto di tutela individuale dei dipendenti, sostituendo alla visione del movimento del lavoro come soggetto politico collettivo e comunitario, l’idea di una federazione pulviscolare di tanti singoli individui che devono essere, ognuno separatamente, protetto e sostenuto nei suoi comportamenti. Nella temperie culturale che sta spostando a destra perfino aree come la Svezia e la California, diventa qualcosa di più di una resa: una vera e propria organica integrazione nel processo di individualizzazione sociale: un “noli me tangere” anche in fabbrica.
Affiora qui un secondo elemento che attraversa tutte le dichiarazioni del segretario generale della Cgil susseguitesi alla sua prima intervista al “Corriere della Sera” del primo agosto, ossia il fatto che il lavoro non pone più al centro della sua azione la contesa della gestione delle relazioni sociali e industriali, e tanto meno la titolarità della strategia complessiva che proprietà e governo elaborano nel campo economico, ma solo il grado di tutela e di certezza dei diritti individuali che ogni dipendente, appunto, deve poter farsi riconoscere.
Una cultura di marca più propriamente cislina, che scarica proprio nelle rivendicazioni aziendali il proprio radicalismo, esorcizzando ogni contrapposizione politica e ideologica sul terreno più esplicitamente di potere. Si torna, paradossalmente, alle origini della separazione che vide nel lontanissimo 1948 rompersi l’unità sindacale, per ricomporsi poi, dopo l’autunno caldo, proprio con il ritrovarsi nel sindacato unitario dei consigli attorno a una negoziazione di valore sull’autonomia del movimento del lavoro dal comando della proprietà. A trent’anni dalla caduta del Muro, non si vuole certo riproporre oggi “il nuovo modo di fare l’automobile”, come si diceva nei primi anni Settanta, quando si metteva in discussione la verticalità dei sistemi gestionali in fabbrica.
Piuttosto, nella nuova società dell’automatizzazione delle relazioni sociali – di cui il lavoro è parte rilevante ma non esclusiva e nemmeno preponderante –, lo spettro che si presenta riguarda la soggettività politica del sistema sociale di produzione che intreccia lavoro e saperi, in una schermaglia continua con i centri di controllo dell’innovazione, per rivendicare una centralità dello spazio pubblico proprio nella fase di applicazione dei saperi alla vita di ognuno di noi. La pandemia ha proposto come versante conflittuale la strategia di contrasto al virus. Chi deve decidere, in virtù di quali obiettivi e valori, e con quali procedure?
O, ancora meglio, da quale gamma di bisogni e ambizioni sociali devono farsi guidare i saperi e la ricerca? Dalle eccentriche trovate di Elon Musk, dalle semplificazioni produttive di Amazon, o da un’etica sociale collettiva in cui il calcolo è supporto non antagonista alla convivenza di tutti?
Attorno a queste domande la destra ha preso l’iniziativa, intuendo che la pandemia avrebbe radicalizzato proprio la funzione di spartiacque dello Stato come motore sociale contrapposto a una individualizzazione che, usando la clava della libertà, o meglio la libertà come una clava, mira a diluire ogni idea di comunità, di primato del pubblico, nella soluzione della crisi. In tutto il mondo lo scontro è fra vaccini e “no vax”, fra Stato e anarco-individualismo, fra sicurezza sociale e liberismo.
Uno scontro che ha dapprima portato gli imprenditori a cavalcare le suggestioni minimaliste della pandemia (la narrazione del virus come semplice influenza, o quella, dell’estate scorsa, del virus “morto”), mentre oggi essi – di fronte a una guerriglia del Covid-19 che, con le varianti, buca le difese vaccinali se non viene recintato da una rigida sorveglianza territoriale, capace di integrare i vaccini con processi di tracciamento e sequenziamento di massa – cercano di essere i programmatori della ripresa, assicurando, con le vaccinazioni interne, la messa al riparo delle aziende. In questa strategia fa capolino un patto neocorporativo, che vede le imprese combinare vaccini e premi di produzione in una logica di privatizzazione completa dell’assistenza e della previdenza.
In questo balletto, che non a caso vede la Cisl muoversi con più disinvoltura e cinismo, soffiando sul fianco scoperto della Cgil, Landini sceglie di assicurarsi il controllo della base leghista del suo sindacato, soprattutto al nord, ammiccando alla tutela dei singoli dipendenti e abdicando completamente alla missione di controparte non solo sul reddito ma sul potere di governo della proprietà nelle aziende.
Una svolta che, nei prossimi mesi, segnerà profondamente la nuova identità sindacale, con una trasformazione degli ambiti più propriamente politici, come le grandi camere del lavoro, in centri di coordinamento dei servizi di patronato, in cui la Cgil diventa consulente del paniere di welfare aziendale che, dipendente per dipendente, si sentirà proporre. Laddove la persistenza della pandemia porrà sempre con più insistenza il tema della titolarità della politica sanitaria come bussola delle relazioni sociali nel mondo della scienza e del sapere.
L’uscita del segretario degli edili, che abbiamo richiamo in apertura, dice però che la partita è ancora aperta. L’accoppiata vaccini più algoritmi sociali, che proprio Genovesi richiama, individua una materialità moderna del nuovo conflitto di potere: competenze e scienza come terreno negoziale di una nuova visione dello Stato. Non si tratta di richiedere una legge da applicare, come sollecita Landini, ma di giocare tutto il peso del sindacato in una nuova etica pubblica, in cui l’appartenenza a una comunità prevalga sui pruriti individualistico-elitari degli Agamben e dei Cacciari, ricostruendo una nuova idea di territorio come collettivo sociale. Consoliamoci allora constatando che la vecchia talpa può ancora scavare a sinistra.









