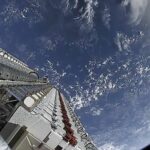Chi avrebbe detto, a sinistra, solo un paio di anni fa, che il bitcoin sarebbe stato il tutore del dollaro? E che i media sarebbero stati sistemi strategici nella guerra ibrida? Quasi nessuno. E lo stupore con cui oggi guardiamo questi fenomeni lo dimostra. Le crisi finanziarie – scriveva un cinico banchiere milanese – servono a separare il denaro dagli incompetenti. Potremmo dire, dinanzi al dilagare del sovranismo e al relativo mutismo delle sinistre nelle loro diverse versioni, che le crisi politiche servono a separare il consenso dalla inadeguatezza politica. Lo scenario presenta infatti tali evidenze della grettezza con cui la destra sovranista viola ogni principio dello stesso capitalismo, che solo l’improponibilità delle alternative spiega razionalmente il mantenimento del consenso verso questi governi autarchici.
Il caso americano, nel suo parossismo, è emblematico. La presidenza Trump – nelle due versioni, quella di otto anni fa, ancora tutta interna alle regole di uno Stato imperiale, e l’attuale, con il caotico attacco alla stessa idea di Stato – mostra quale sia oggi la tendenza di un capitalismo che sembra non avere ancora ricomposto l’equilibrio fra i vecchi potentati geopolitici e le nuove ambizioni anarco-mercantili. La domanda che potrebbe aiutarci a fare chiarezza, in questo gorgo sociale, l’ha posta in un intervento su “Repubblica”, qualche settimana fa, il presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Zuppi, quando si chiedeva “quale popolo abbiamo dinanzi?”. Un quesito che dovrebbe incitarci a chiederci – piuttosto che invocare retoricamente quanto mai improbabili e generici ritorni al popolo – quale sia oggi l’accezione reale di questa categoria.
Il capitalismo, o diciamo la sua versione più radicale e selvatica, ha reinventato il popolo. Una straordinaria operazione di ingegneria sociale, condotta con una metodologia prettamente “marxista”, in cui sono stati selezionati bisogni, istinti, emozioni, riempiendo il buco nero che il crollo del mondo sovietico aveva scavato nell’immaginario collettivo: non si combatte il padrone che ti sta davanti, ma si allontana il tuo simile che ti sta alle spalle. La paura ha sostituito la speranza. Senza il sole dell’avvenire del socialismo, che prometteva un nuovo destino, rimaneva solo il premio di produzione che ti poteva concedere il padrone, a condizione che la globalizzazione non abbassasse troppo i prezzi e l’immigrazione non svalutasse troppo il lavoro.
La matrice – marxista appunto – di questo processo è sempre il lavoro; ma in questo caso in negativo: la marginalizzazione del lavoro vivo a vantaggio di un lavoro automatico, meglio ancora, in termini gramsciani, l’egemonia di un modello sociale in cui individualmente si accede a potenze di calcolo che riducono dipendenza e necessità del comune, cioè del farlo insieme. Come spiegava Hannah Arendt, il totalitarismo della prima metà del Novecento prende forma sottraendo all’azione popolare il comune: la densità di un protagonismo collettivo, sostituito da una mera protesta plebiscitaria.
La sinistra ha assecondato questa parabola, pensando di accreditarsi come buona amministrazione e non orchestratore di comune. Oggi si ripete questa alchimia: il carattere reticolare delle relazioni digitali è stato spolpato del suo valore comunitario – il concetto di “comunità” come ponte fra società e produzione ci arriva anche da Adriano Olivetti –, diventando aggregazione vociante attorno a potenze di ingaggio. La proprietà quantistica dell’engagement, della relazione anonima e distante fra due particelle, che a loro insaputa si muovono all’unisono, è il motore della società sovranista. In un profetico saggio (intitolato Reti di indignazione e speranza) del 2012 – anno fatidico in cui si ratifica l’uscita della sinistra dalla storia, dopo le cosiddette primavere arabe e le “rivoluzioni arancioni” – Manuel Castells, uno dei padri della trasformazione digitale della società contemporanea, colse il punto di svolta delle relazioni sociali nel pianeta: “I movimenti sociali non sorgono più dalla povertà e dalla disperazione (…), quanto da una mobilitazione emotiva innescata dall’oltraggio per le palesi ingiustizie e dalla speranza ingenerata dal successo altrui”.
La lotta di classe non evapora, cambia forma e protagonisti. I segni prevalgono sui sogni. E la pianificazione di modelli sociali, medianti sistemi digitali, sostituisce la novecentesca contraddizione capitale/lavoro: i calcolanti cominciano a governare i calcolati. È il miraggio dell’imitazione del successo altrui, non la fame, che spinge i poveri a pensare come i ricchi. Per questo – aggiunge Castells – “il potere è esercitato tramite la costituzione di significati nell’immaginario collettivo. La comunicazione è il processo di condivisione dei significati”.
L’offensiva per omologare il mondo sulla spinta della padronanza di questi messaggi fu guidata non dagli Stati, e nemmeno dai complessi militari-industriali, ma direttamente da gruppi monopolistici privati che parlavano, separatamente da ogni infrastruttura pubblica, direttamente con ognuno dei propri miliardi di utenti. Prendeva così velocità la spinta a scavalcare gli Stati, intesi ormai come semplice burocrazia prescrittiva.
Nel 2012, mentre in Italia a sinistra si discuteva di Renzi e di “terza via”, a Mosca prendeva forma la strategia della guerra ibrida che l’anno successivo portò a Cambrige Analytica come format per neutralizzare le elezioni mediante procedure di profilazione e persuasione molecolare degli elettori contendibili. Ha inizio da qui quella “rivoluzione dall’alto” che Marx aveva intuito come passaggio dal capitalismo del lavoro al modello immateriale. “La lotta di classe dopo la lotta di classe è un’espressione che si riferisce alla persistenza e alla trasformazione del conflitto sociale, non più limitato alla tradizionale contrapposizione tra borghesia e proletariato, ma esteso a una lotta ‘dall’alto verso il basso’. In questa nuova fase, le classi dominanti, individuate come ‘vincitrici’, intraprendono una lotta attiva per mantenere il proprio potere e controllo, limitando lo sviluppo di potenziali classi antagoniste”. Proprio nel concetto di “potenziali classi antagoniste”, e non più nella ripetizione della formula del proletariato, sta la genialità della premonizione del Moro, del tutto ignorata dai suoi epigoni, perfino oggi che almeno la disperazione dovrebbe portarli a “cercare ancora”, come chiedeva Claudio Napoleoni.
Il provvedimento con cui Trump, nei giorni scorsi, ha riconosciuto il valore del bitcoin, e più in generale delle criptomonete, come valuta di scambio e non solamente speculativa, integrandola nelle riserve strategiche del dollaro, annuncia una svolta clamorosa. Il Paese guida del capitalismo, che attraverso il signoraggio del dollaro aveva oppresso i Paesi in via di sviluppo, imponendo una tassa mondiale a sostegno del debito americano, libera gli istinti belluini del capitalismo più selvatico, impedendo persino al circuito bancario, o ai grandi centri della Silicon Valley, di controllare un mercato, quello delle criptomonete, assolutamente volatile e imprevedibile.
Perché il più potente centro di comando sulla finanza si spoglia dei suoi poteri, aprendo la strada al modello di block change, il sistema automatico che governa le valutazioni delle criptomonete? Perché l’obiettivo è lo Stato. Meglio ancora: sbaraccare il campo da interferenze pubbliche alle dinamiche private. È l’inizio di un’offensiva contro ogni dimensione istituzionale che richiami il patto sociale del Novecento fra capitale e lavoro. Il primo, ormai, ha una struttura neurologica, il suo obiettivo non è il plusvalore ma il plus-umano, condizionare l’evoluzione della specie; mentre il secondo si è scomposto in cunicoli di automazioni e prestazioni, che ormai non producono più coscienza di sé. La comunicazione, come rilevava Castells, è il braccio armato di questa mediamorfosi. Non sotto forma di propaganda ma di interferenza. Si combatte – spiegava il capo di stato maggiore russo, Gerasimov – “interferendo nel senso comune di un Paese o di un gruppo sociale”. Anche di un individuo.
Per questo, appare singolare pensare di rivendicare un controllo pubblico degli apparati radiotelevisivi, se non si pone il tema della missione di quegli apparati nella guerra ibrida. Ricavando da quella missione, tesa a contrastare le forme di interferenza nell’opinione pubblica mediante l’autonomia nella selezione di linguaggi e sistemi di intelligenza generativa, un cambio di passo che preveda figure professionali e interessi sociali integrati nei sistemi pubblici sensibili alla propria autonomia e indipendenza. È la missione che determina la governance e non viceversa. Così come solo una idea di negoziato sociale intorno ai sistemi di calcolo, che generano una nuova classe sociale, potrebbe far coincidere l’emancipazione di questa classe con la liberazione di tutti. L’attacco allo Stato – ancora di più, al comune, alla socialità – deve essere contrastato con eguale radicalismo, mettendo in campo una visione opposta della convivenza e dello sviluppo, dove la proprietà sia vincolo e limite di un’abbondanza di capacità e opzioni che oggi la tecnologia rende disponibili. Radicarsi nel processo di decentramento delle tecnologie generative, rovesciando la personalizzazione in condivisione e ricreando modelli collettivi di potenza computazionale, significa affrontare l’avversario per quello che è, intervenendo nella sua catena del consenso che connette corporativismo manifatturiero con nazionalismo bottegaio, mediante la mano libera concessa ai monopoli digitali.
Non basta dire più Stato, bisogna concretizzare una visione di sinistra – marxiana, diciamo pure esplicitamente, e comunista – di superamento dello Stato mediante la democrazia e non l’autocrazia. Le tecnologie permettono oggi di condividere competenze e decisioni. Non è la difesa di costituzioni antiche che ci salverà, ma una pratica che superi in velocità la trasformazione della democrazia rappresentativa nella direzione di una comunità di eguali.