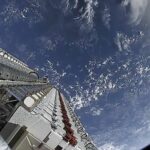La grande parata in piazza Tienanmen ha prodotto una singolare convergenza di attenzione, se non di trasporto emotivo, fra ceti moderati o apertamente reazionari del Paese e una certa sinistra inossidabile ancora in cerca di rivincite sul 1989. Sarebbe utile ragionare su quest’assonanza di apprezzamenti, caricati di rancoroso sarcasmo nei confronti della povera Europa, che si concentravano su quella congrega di regimi autoritari, o esplicitamente dittatoriali, capeggiati oltre che dai padroni di casa cinesi, dalla Russia di Putin, che sventolava la bandiera zarista di San Giorgio, accanto al quale scodinzolava il leader nord-coreano, insieme con iraniani, turchi e pakistani. Fra loro – non senza un certo spaesamento – il presidente brasiliano Lula appariva un ostaggio da esibire ai fotografi, mentre l’indiano Modi, che stringeva sorridente tutte le mani che gli capitavano a tiro, era ben attento a non capitare vicino ai vertici pakistani che stanno minacciando il suo Paese con le armi appena comprate dalla Cina. Nella conviviale foto finale, ha trovato posto – in alto, molto in alto a sinistra – anche l’ex presidente del Consiglio italiano Massimo D’Alema, con la qualifica di osservatore non si sa bene di cosa.
La pressione deve essere stata registrata anche dal Quirinale, dove il presidente Mattarella ha sentito la necessità di usare il messaggio da mandare all’annuale ritrovo di Cernobbio per lanciare un grido d’allarme: l’Europa rimane un’isola di democrazia da difendere contro l’assedio di Stati autocratici e anche di imperi tecnologici privati – la nuova Compagnie delle Indie, come si può definire la Silicon Valley. In questo accostamento troviamo forse la chiave per interpretare la convergenza degli opposti estremismi – si potrebbe dire – che si registra in favore dei regimi autoritari. Una chiave che dovrebbe aiutarci a riflettere sull’impasse, ideologica prima ancora che politica, di sinistre in cerca di identità e di ruolo.
La banale richiesta di dialogo anche a Est, con cui D’Alema ha giustificato la sua presenza, coronata da una trionfale intervista a uno dei canali minori della tv cinese – in cui ha glorificato il ruolo storico della Cina sia nella lotta contro il fascismo e il nazismo, sia nel presente per l’emancipazione dei popoli –, appare quanto meno superficiale, se non contraddittoria. Il nodo su cui lo stesso D’Alema si era soffermato nelle sue ultime sortite in Italia, quando parlava da ex presidente del Consiglio e non da amministratore delegato di una società di consulenza nella commercializzazione di tecnologie di vario tipo in cerca di clienti, che muta radicalmente lo scenario di una contrapposizione Est/Ovest, sta in una dissoluzione del polo occidentale.
Le acrobazie dell’inquilino della Casa Bianca, addebitate tout court alle responsabilità europee, segnalano piuttosto una convergenza di una parte non marginale del capitalismo americano con il fronte orientale, che – proprio come Trump – considera la democrazia una burocrazia superata. In questo rapporto torbido e ancora da decifrare, in cui non mancano echi delle intrusioni di gruppi hacker nelle due elezioni del presidente statunitense (come documentato nelle inchieste di Cambridge Analytica), si sta giocando una nuova partita, dove quel fronte che abbiamo visto estasiato dinanzi alla sfilata di missili cinesi non è certo un portatore né di libertà né, tanto meno, di potere negoziale per le classi subalterne europee. Tanto è vero che ancora oggi, nel pieno della guerra in Ucraina, con la conclamata mobilitazione contro l’aggressione russa, constatiamo che il grosso dei grandi gruppi industriali e tecnologici mantengono intatti i propri rapporti economici sia con i russi sia con i cinesi. L’altalena dei dazi agitata da Trump non è il segno di un revanscismo del capitalismo liberale, ma la dimostrazione di dove andremmo se i regimi autocratici prendessero il sopravvento.
A differenza di quanto l’Urss, nei suoi 75 anni di vita e d’influenza internazionale, nonostante l’involuzione totalitaria e burocratica del suo regime interno, ha garantito nella costante pressione sul capitalismo – costringendo il mercato solo con la sua ombra egemonica e la minaccia ideologica a scendere a patti con i movimenti del lavoro –, le potenze asiatiche sono oggi caratterizzate da un’ibridazione perniciosa fra un esasperato mercantilismo e l’assenza di ogni ambizione di liberazione sociale. Non sono opzioni strategiche alternative al capitalismo ma degenerazioni del sistema di sfruttamento, che mirano a strappare privilegi per le proprie élite di comando, senza effetti di destabilizzazione, o almeno di correzione, delle relazioni sociali a livello internazionale. Questa è la realtà che si è ritrovata emblematicamente in piazza Tienanmen: un polo di competizione ipercapitalista privo dell’impaccio della dialettica sociale.
Infatti, più che la democrazia rappresentativa, che sta consumando le sue ultime energie, quello che oggi è al centro di una contesa antropologica, prima ancora che ideologica, è la dimensione del comune, ossia di uno spazio pubblico che non coincide né con la proprietà privata né con la centralizzazione statalista. Come spiegava Hannah Arendt, i regimi fascisti europei, e totalitari in genere, hanno sottratto alla politica lo spazio comune della vita sociale, disarticolando ogni relazione e negoziazione socio-politica.
Nella società digitale, dominata da processi di automazione delle decisioni, il presupposto per ingegnerizzare comportamenti coerenti con i processi tecnologici è appunto quello di rimuovere ogni attrito. Come spiegava Elon Musk, nella fase del suo impegno nel governo di Trump, “bisogna sostituire le regole con i dati”. Questo è il tratto che congiunge e identifica i regimi russo e cinese (o iraniano) con la nuova presidenza americana: rendere automatiche le decisioni, saltando ogni intermediazione istituzionale.
Su questo punto il luciferino D’Alema avrebbe dovuto cogliere il vero buco nero della sinistra europea, invece di lasciarsi andare, dopo averlo fatto con le élite anglosassoni al tempo della sua presidenza del Consiglio, all’ennesimo elogio di chi comanda: quali processi conflittuali innescare per rigenerare la democrazia, non per sostituirla con una semplificazione autoritaria?
La mancanza di ogni intervento o considerazione da parte dei dirigenti delle diverse sinistre nazionali testimonia di un’estraneità totale a ragionare in questi termini. Mentre si surriscalda il fronte della contesa, fra il fronte del Pacifico, dove si ritrovano gli Stati Uniti di Trump, la Cina di Xi e la Russia di Putin, contro la comunità dell’Atlantico, dove Europa e Americhe centromeridionali, con cui si è stipulato il nuovo patto del Mercosur, si interrogano su come darsi autonomia e protagonismo senza il “grande fratello” statunitense, a Roma si preferiva occuparsi della candidatura in Puglia, soddisfatti di avere trovato l’ennesimo stratagemma locale per fingere di essere uniti.
Il premio Nobel dell’economia Stiglitz, in un’intervista a “Repubblica” di domenica 7 settembre, offre una schematica ricetta per non soccombere in questo scontro di civiltà: indipendenza strategica dell’Europa, con una propria difesa e un pieno controllo delle tecnologie mediante un modello partecipativo e trasparente, alternativo ai monopoli americani e ai sorveglianti asiatici. Un programma non dissimile da quanto proposto qualche giorno fa da Draghi, con l’aggiunta di una negoziazione sociale della potenza di calcolo, che metta in campo nuove comunità di contesa e conflittualità digitale. A meno che D’Alema non abbia la sua ennesima altra idea.