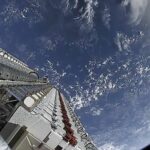Il rimpianto per le grandi stagioni della combattività operaia e sindacale dovrebbe essere temperato dalla constatazione che quello che manca oggi non sono tanto le azioni conflittuali, quanto la coscienza di classe, ossia la maturazione di una visione alternativa della convivenza sociale, non più basata sulla proprietà e il profitto, ma sulla solidarietà e la condivisione. In questi ultimi mesi, in molti Paesi europei, si segnala una consistente impennata dalle lotte sindacali nella gig economy (vedi qui). Diciamo dai magazzini di Amazon alle microaziende pullulanti di riders, lungo tutta la filiera del mercato dell’algoritmo.
Si parla di adesioni agli scioperi dell’80%, rinverdendo i fasti degli anni Settanta. Una vera spallata – avremmo detto qualche lustro fa – che non produce però né consapevolezza sociale di modelli gestionali diversi, né tanto meno una domanda di rappresentanza politica collettiva, che potrebbe ridare slancio a una sinistra del conflitto. Sia in Spagna, sia in Francia o in Germania, le forme di contesa sociale che pure non mancano – dai fuochi che stanno incendiando le città transalpine alle instabilità sociali spagnole – non appaiono in qualche modo agganciate alle rivendicazioni dei lavoratori sfruttati dai gruppi digitali. In molti casi, vediamo le stesse figure sociali scioperare alla mattina come dipendenti di questa o quella ditta digitale, e al pomeriggio invece manifestare nelle periferie delle grandi città contro élite e partiti, che spesso sono parte della cultura di sinistra. In sostanza, il tema che queste forme ibride di rivolta sociale ci pone riguarda il fatto che il lavoro, questo tipo di lavoro subalterno diffuso nelle società avanzate, non produce più quella coscienza di sé, o quella domanda di cambiamento, in grado di egemonizzare le altre ragioni di disagio popolare.
Un riferimento storico potrebbe aiutare a mettere a fuoco il problema. Nei primi anni Sessanta, nel pieno del miracolo economico, nelle grandi città del Nord Italia – il famoso triangolo industriale – regnava la bonaccia sociale. Lo sviluppo impetuoso dell’industria, con lo spostamento dal Sud al Nord di milioni di persone, non sembrava produrre lotta né sindacale né politica. Alle spalle,nel 1955,la famosa sconfitta della Cgil nelle elezioni sindacali alla Fiat, aveva mortificato le ambizioni del sindacato di Di Vittorio, che pure aveva chiarissimo che lo scontro sociale non poteva che giocarsi nel punto alto dello sviluppo, e non rintanandosi negli insediamenti popolari e bracciantili tradizionali.
Italo Calvino scriveva , nel 1957, la nota allegoria sull’immobilità del Pci La grande bonaccia delle Antille, in cui metteva alla berlina non tanto l’intraprendenza del galeone di Botteghe Oscure, guidato dal “capitano”, dietro cui era facile intravedere la sagoma di Palmiro Togliatti, quanto la miopia di un’ortodossia sociale e politica che isolava il più grande partito della sinistra italiana dalle novità che maturavano in un Paese che correva freneticamente verso il neocapitalismo, mentre la sua cultura ideologica voleva ancora dominante la visione delle famose bandiere della democrazia e del progresso, che la borghesia lasciava cadere nel fango e i comunisti dovevano raccogliere, realizzando quelle riforme che il centro moderato non era in grado di fare.
In pochi mesi però – dai famosi moti del luglio 1960, con i ragazzi con le magliette a strisce, al 1962, con gli scontri di Piazza Statuto a Torino contro i sindacati gialli della Fiat, e i poderosi scioperi degli elettromeccanici di Milano – improvvisamente il galeone prese il mare, nonostante onde alte e venti di burrasca. Si ebbe una svolta che permise alla sinistra di cambiare la cassetta degli attrezzi, intercettando le domande di una “razza pagana”, come un giovanissimo Bruno Trentin definiva i nuovi operai immigrati, che non sapevano niente di ideologia ma avevano chiaro che volevano vivere meglio e che, per fare questo, dovevano cambiare i rapporti di forza in fabbrica. Spiegava Antonio Pizzinato – promettente quadro operaio della Borletti inviato a studiare a Mosca, che, tornato in fabbrica, comprese subito la qualità e la natura dei bisogni espressi da quelle migliaia di ex braccianti assiepati nei casermoni dei quartieri dormitorio di Milano e Torino – in un’intervista rilasciata a chi scrive nel volume Avevamo la luna (Donzelli editore): “Inseguivamo l’aristocrazia operaia e scoprimmo l’operaio massa che voleva vivere e pretendeva di contrattare il modo in cui si passava il tempo alla catena di montaggio”. Si cambiò marcia subito: le lotte operaie cominciarono a parlare ai nuovi ceti urbani, incubando la stagione della libertà che maturò qualche anno dopo, con l’autunno caldo.
Oggi ci troviamo in un tornante non dissimile: le lotte, quando ci sono, rimangono mute, e vengono sovrastate da bisogni sociali che la destra trasforma in vandee antidemocratiche. In discussione sono sia le condizioni di lavoro, a cominciare dai ritmi scanditi anonimamente da algoritmi lontani, sia le retribuzioni che rimangono ancora scandalosamente basse.
Ma rispetto alle stagioni che abbiamo richiamato, ciò che appare evidente è che queste rivendicazioni si basano, nel migliore dei casi, esclusivamente su una richiesta di graduale miglioramento, diciamo di condizioni meno incivili, del rapporto di lavoro, senza alcuna ambizione di mutare la geometria dei poteri. La natura del rapporto di lavoro, basato sulla volontà esclusiva del proprietario, e la gestione dell’apparato produttivo, che dipende solo dall’ottimizzazione dei profitti trimestrali, non sono minimamente scalfiti da queste turbolenze. Si porta al tavolo del negoziato la disperazione di chi si trova da anni a pedalare con una gerla termica sulle spalle, oppure a ripetere ossessivamente, esattamente, quattro movimenti per sollevare o rilevare un pacco in uno scaffale. Un rancore cieco che viene poi canalizzato (in Francia) dall’odio urbano delle banlieues.
Queste figure trovano proprio nella frustrazione reciproca un occasionale momento di contatto, che squarcia la solitudine individuale di ognuno nello sciame che produce. Una condizione che si verifica in tutte le latitudini della fabbrica digitale: dalle grandi piattaforme americane, ai terminali europei o asiatici di questi imperi che profilano i desideri e, telepaticamente, ne promuovono la soddisfazione.
Questo quadro globale dice che l’evidente crisi della sinistra – ormai ridotta, in ogni contesa elettorale, ai minimi termini – è strettamente legata all’irrilevanza di ogni possibilità di rappresentare l’alterità del mondo del lavoro rispetto al nuovo “capitalismo della sorveglianza”, che spiega come il sortilegio di questa nuova tipologia del mercato stia proprio nella sua capacità di “esiliare ognuno di noi nella sua esperienza”. Definizione di una perversa perfezione nel cogliere il meccanismo di questa nuova economia in cui, labirinticamente, ognuno di noi, a qualsiasi livello si collochi, persino nelle élite, si trova del tutto estraneo, o comunque collaterale, ai punti di reale decisione che interferiscono non solo nello scambio economico fra risorse e produzione, ma proprio nei più intimi meccanismi della nostra mente. È il controllo di questa interferenza – scriveva Remo Bodei nel suo ultimo saggio, intitolato Dominio e sottomissione – che reifica il potere dei padroni del calcolo, i calcolanti, sulla massa sterminata dei subalterni, i calcolati.
Veniamo così al nodo che proprio la conflittualità senza sbocco di Amazon e dintorni propone: come continua la storia se la proprietà diventa l’unica immutabile motrice di ogni relazione? E come ci si rapporta a una società in cui il controllo di pochi apparati di calcolo permette di condizionare miliardi di individui, accumulando fortune stratosferiche e riducendo ogni altro essere umano a pura marionetta dei propri dati?
Si arriva così alla soglia dell’intelligenza artificiale. Con l’irruzione sulla scena di tendenze che vedono ogni individuo potere accedere a sistemi automatici di elaborazione infinita di dati, e di integrazione inesauribile di conoscenza, come può cambiare la scena digitale? Se anche i riders di Amazon possono dotarsi di sistemi di calcolo, che li supportano nel coordinamento e nell’ottimizzazione della loro attività, cosa chiederanno al loro padrone?
Proprio da Hollywood, nel tempio dei segni e dei sogni, dove il “capitalismo della sorveglianza” era diventato innanzitutto mercato dell’immaginario, emerge una proposta che potrebbe rimettere in azione la “vecchia talpa”: la contesa sui dati. Se i dipendenti delle piattaforme, insieme agli utenti, anche attraverso alcuni testimonial collettivi, come possono essere appunto gli sceneggiatori del cinema o i giornalisti, oppure i medici, dovessero rivendicare (come le norme europee peraltro autorizzano) il pieno possesso dei propri dati, contestando a Google o a Netflix una gestione esclusiva e speculativa, si aprirebbe un nuovo ciclo del lavoro, in cui ognuno, meglio se collettivamente, potrebbe trovare opportunità e prospettive in un mercato di scambio di informazioni e dati per personalizzare servizi e prodotti, senza rimanere schiavo dei calcolanti. Questo si potrebbe fare. E in questa logica la rappresentanza politica riacquisterebbe nerbo, diventando non un ennesimo facilitatore del mercato, ma una nuova versione di quella suggestione che per un secolo fece tremare i potenti.