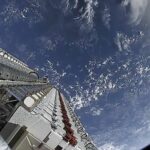A Milano la politica “rimugina” dopo, non progetta mai prima – scopre solo ora Michele Serra su “Repubblica”. Nella stessa pagina, Pier Francesco Majorino, ex assessore della prima giunta Sala e attualmente europarlamentare, astro nascente di un Pd sociale, non senza imbarazzo conferma che il suo partito, mentre esprime solidarietà al sindaco, auspica un cambio di passo. Rimugina, auspica: verbi che lasciano intendere quale sia il vero reato commesso a Milano: la rimozione di ogni impaccio democratico, di ogni procedura partecipativa, di ogni sede pubblica di discussione delle decisioni amministrative, tutta roba omologata come un’insopportabile burocrazia. Non bisognerebbe scomodare Max Weber e neanche Jürgen Habermas, per dare forza a un’idea di spazio pubblico o di senso dello Stato, e per legittimare la democrazia rappresentativa considerata a Milano alla stregua di lacci e lacciuoli.
Il tema è fondante per le precarie speranze di una ripresa di un protagonismo della sinistra sulla scena globale. È un tema dirimente anche per noi di “terzogiornale” che, non volendo rifugiarci in necrofili riti di celebrazione del buon tempo antico, siamo costretti a misurarci con i temi più spietati e crudi del dibattito politico, al di fuori di ogni tatticismo o micro-machiavellismo, che tra l’altro le nostre dimensioni renderebbe velleitario e ridicolo. Proprio perché siamo piccoli dobbiamo pensare in grande.
Quanto sta accadendo nella metropoli meneghina è un affare tutto politico, in cui i magistrati si aggiungono ma non determinano. Questa è la differenza vera con la mitica “mani pulite” di più di trent’anni fa. Il caso Milano arriva proprio quando in città andava in scena il solito copione della ricerca di un centro virtuoso che avrebbe modernizzato il Pd, grazie all’invasione da parte di un immaginifico ceto moderato ma riformatore. Gli aspetti giudiziari, con la valanga di avvisi di garanzia e le decine di richieste di arresti, rischiano di essere l’ennesima turbativa rispetto al dibattito in corso. Ma facciamo conto che tutto si riveli una bolla di sapone, proceduralmente. Diciamo pure che si arrivi a un non luogo a procedere. Tutto bene? Possiamo inscenare l’indignazione di istituzioni violentate dallo zelo di pubblici ministeri in vena di protagonismo? Al netto degli aspetti penali, non è affiorato niente di istituzionalmente rilevante?
Il coro delle zoccolanti in difesa del primato della politica – capeggiato dall’intemerato direttore del “Foglio”, Cerasa – può lanciare il grido “Sala è uno di noi”? È davvero quello il primato della politica da difendere: non disturbare il manovratore, chiunque esso sia? Non ci sarebbero altri aspetti da valutare per capire come cambiare passo, come chiede sommessamente Majorino?
Due sono gli aspetti che, ai fini di un dibattito di fondo sull’identità della sinistra, non possono non balzare agli occhi. Il primo riguarda la trama, nel senso tessile del termine, l’intreccio, che congiunge persino nelle somiglianze fisiche, il ceto amministrativo, diventato centro di deliberazione istituzionale, e il milieu affaristico. Dall’ex assessore Tancredi ai diversi componenti dell’ormai famigerata commissione Paesaggio del Comune, fino a quella corona di figure intermedie, quali architetti con pulsioni bonapartiste, che dettano l’agenda al sindaco, stiamo scoprendo come la governance della città sia stata appaltata dalle istituzioni rappresentative a cenacoli tecnici, in cui funzionari della burocrazia comunale sono diventati direttamente decisori, senza nessuna verifica o espressione politica, senza che in nessun luogo, sia esso elettorale o di partito, si siano confrontate proposte o capacità.
Questo è il primo buco nero: la tecnocrazia ha sostituito ogni forma di rappresentanza democratica, appiattendo programmi, bisogni e proposte in un unico magma funzionale. Un fenomeno, del resto, ampiamente simboleggiato dallo stesso sindaco: Sala, da ex city manager della sindaca di centrodestra Moratti, è diventato capofila della giunta di centrosinistra, sostituendo ogni protagonismo dei partiti che costituivano la maggioranza in Consiglio. Basterebbe chiedere ai silenziosi e distratti dirigenti del Pd milanese a quando risale l’ultimo convegno o forum sul piano regolatore della città. Oppure quando si sia organizzata una riunione della segreteria, o del direttivo del partito, sui temi quali le varianti che venivano sfornate industrialmente dai tecno-decisori.
L’edilizia non è più la vecchia fabbrica delle costruzioni, che procede da vaghe committenze iniziali e progetti intuitivi che si realizzano gradualmente, come una volta. Oggi ci sono le nuove tecnologie sociali, capaci di riprodurre, scannerizzare, elaborare il profilo di interi quartieri, identificando, uno per uno, ogni singolo abitante, i suoi movimenti e bisogni. Sulla base di questi dati, i renderings dei progetti sono modelli predittivi che mostrano, dettagliatamente, ogni variante immobiliare, e permettono di evidenziare, appunto in chiave predittiva, ogni impatto sul territorio. Il piano regolatore è un vero videogame che anticipa il film della città che sarà. Ma chi ha discusso di questo? Quando, dove, con chi? Questo è il vero reato di lesa maestà: la confisca delle potenzialità di partecipazione democratica proprie degli aspetti anche maggiormente tecnologici delle nuove realtà.
Il secondo buco nero, che è causa del primo, riguarda la natura dei partiti. Milano è forse la città italiana più intimamente e molecolarmente globale. In questa città, si è vissuta prima la mutazione genetica craxiana – che nel Pci trovò una sua esemplificazione in quella leva di valenti (niente da dire) amministratori “miglioristi”, che sostituirono i fini con i mezzi, sacrificando all’ambizione del governo ogni attrito sociale, ogni ambizione di elaborare strategie politiche che non fossero di pura attuazione del laissez faire del mercato globale – e poi lo shock di “mani pulite”, che colpì la democrazia rappresentativa più che la tecnocrazia predatoria, smembrando e inibendo ogni apparato politico territoriale.
Da questa evoluzione è uscita una città che ha derubricato la politica a cultura dei diritti, rimuovendo ogni conflitto economico e gestionale. Il leghismo è stato recintato da un ceto liberal e cosmopolita; in cambio, le amministrazioni sono state dei circoli di arti e mestieri, dove le corporazioni cittadine erano direttamente rappresentate. La sequenza Moratti-Pisapia-Sala ha snaturato ogni rappresentatività sociale, limitando alla cultura delle imprese il diritto a interloquire con la macchina comunale. Gli assessori erano direttamente ex manager che coltivavano gli stessi interessi negli uffici pubblici. Fino al passaggio finale, in cui, appunto, il capo della tecnocrazia comunale diventa sindaco, e raccoglie attorno a sé i suoi omologhi dei diversi assessorati.
Il partito assiste muto, misurando gli effetti elettorali, per capitalizzare sotto forma di elezione al parlamento dei suoi dirigenti locali. Emblematico il passaggio da Milano Expo al polo biotecnologico, che vede un pezzo dell’area metropolitana giocare una grande partita a livello globale, senza che questo abbia minimamente coinvolto i ceti intellettuali e gli apparati della ricerca. Non è un caso che l’unico tema su cui si è accesa una fiammella di mobilitazione sociale sia stato il destino dello stadio di San Siro, su cui si sono concentrati gli appetiti dei gruppi finanziari e un senso di autodifesa della componente sindacale della città, che ha promosso un presidio dell’affaire, impedendo che diventasse l’ennesima Scia, ossia una procedura amministrativa automatica.
Ora, il nodo che si dovrebbe affrontare riguarda il governo pubblico di quel patrimonio europeo che è il futuro della città. Un futuro che qualcuno ha già programmato, concependo Milano come un quartiere di scarico delle attività che Londra e Parigi, per motivi diversi, non reggono più, e che Amsterdam non è in condizioni di assorbire. Parti delle burocrazie dell’inner circle europeo, insieme con apparati di aziende e imprese private, stanno trasferendosi nei grattacieli più esclusivi della città, sostituendo quell’emorragia di residenti che non reggono più il costo della vita. Milano così sta assomigliando ai suoi speculatori, e la politica sta diventando la vera estranea. I partiti diventano appunto una Scia, una pratica automatica.
Su questo tema, bisognerebbe riprendere pubblicamente la parola, ridisegnando un sistema amministrativo che possa governare reti di connettività, flussi di dati, tipologie di energie, centri di calcolo. Se non si affronta la testa del serpente – di cui i palazzinari sono modesti funzionari e non quei giganti che sembrano rispetto agli impiegati comunali – non ne usciamo a sinistra. Come spiega il politologo americano Ian Bremmer, l’unica cosa peggiore di attraversarla, per una comunità, è quella di sprecare una crisi.