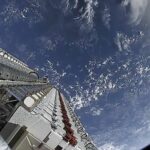Chi può mettere in dubbio un algoritmo? si domandava, una decina di anni fa (eravamo ancora lontani dagli attuali dispositivi personalizzati di intelligenza artificiale), Frank Pasquale nel suo Black Box Society. Il titolo sembrava un paradosso, oggi è diventata piatta cronaca. Siamo infatti nel pieno di una “black box society”, intendendo con “scatola nera” quell’insieme di artifici computazionali che mediano e orientano i nostri comportamenti, e di cui persino i proprietari hanno l’improntitudine di dire che non sanno bene come funzionano. Davvero gente fortunata, questi della Silicon Valley, se sistemi di calcoli così misteriosi continuano a produrre inesorabilmente centinaia di miliardi di dollari per i loro fatturati!
Ora, la domanda di Pasquale è diventata, oltre che cronaca finanziaria, cronaca politica. Il nodo riguarda chi può organizzare controlli e regole per costringere gli algoritmi a funzionare in un certo modo. Pensiamo, in questo caso, agli algoritmi di quel fenomeno che chiamiamo guerra ibrida, e che vede interessi privati e potenze straniere intervenire nel gorgo della tracciabilità di ogni nostra azione per orientarla in maniera predittiva. Stiamo parlando di guerra a tutti gli effetti, il cui aggettivo “ibrido” ne modifica la forma ma non il fine: subordinare la sovranità di un Paese, per esempio del nostro Paese.
Ovviamente, il governo è il primo centro di responsabilità che dovrebbe occuparsi della materia: se c’è una guerra, sotto qualsiasi forma, l’esecutivo è responsabile della sicurezza. Ma se c’è una guerra il resto delle istituzioni – dal capo dello Stato, capo supremo anche delle forze armate, al parlamento, sede della volontà popolare – possono essere ignorate? E viceversa, queste istituzioni possono disinteressarsi del tema strategico? Più in particolare, le forze di opposizione possono incalzare il governo sui dazi di Trump e non scoprirne le contraddizioni sul riassetto dei sistemi di sicurezza?
In questi giorni, si sta giocando una partita delicatissima per i poteri costituzionali della nostra democrazia, e proprio attorno al modo in cui attrezzarsi nel quadro della guerra ibrida. Il nostro è stato il Paese più attaccato – circa il 10% delle operazioni di cyber-attacco che si sono realizzate a livello planetario nei mesi scorsi – da squadre di hacker che minacciano il funzionamento di sistemi nevralgici, come sanità e giustizia (ai trasporti non si bada, perché ci pensa direttamente Salvini a hackerarli preventivamente).
Siamo dunque in prima linea. La discussione in corso, sulla legge che disciplina l’intero settore, diventa non solo di rilievo interno, ma inevitabilmente comporta conseguenze sia internazionali, per evidenti conseguenze geopolitiche, sia sul profilo dei poteri costituzionali. Infatti, si è aperto un dissidio fra il ministro della difesa Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano, uomo forte della maggioranza per il controllo dei servizi di sicurezza. Il primo reclama un maggiore spazio per il suo ministero – negli organismi di controllo e nelle sedi di pianificazione delle strategie di cybersecurity. Un protagonismo che dovrebbe inevitabilmente coinvolgere, per le occasioni previste dalla Costituzione, anche il capo dello Stato, la cui responsabilità suprema sulle forze di difesa comprenderebbe anche le attività di contrasto digitale. Contrariamente, Mantovano punta a restringere in un ambito civile – il che significa di puro interesse dello staff del capo del governo – ogni attività di rilievo digitale.
Il dissidio è esploso, singolarmente, alla fine dell’iter della legge, che ormai si trova alla Camera in seconda battuta. Ma non per questo appare di rilievo minore. Si tratta di mettere a fuoco le linee di responsabilità nei conflitti tecnologici che abbiamo visto sono fin troppo concreti. Tanto più se – sullo sfondo – dovesse esserci una riforma dei poteri del presidente del Consiglio, secondo le ambizioni presidenzialiste meloniane.
Per questo appare inspiegabile il disinteresse delle forze di opposizione, che non sono intervenute in merito all’impasse in cui si trova l’esecutivo, e tanto meno hanno avanzato proposte e soluzioni alternative. Il nodo non riguarda solo le linee di comando e di decisione, ma anche l’evoluzione di quella che sarà sempre più una materia fondamentale per le attività contemporanee, come appunto la cybersecurity.
Se ci troveremo – come tutto lascia intendere – sempre più al centro di strategie di sobillazione e manipolazione del senso comune del Paese, dei processi di formazione della sua opinione pubblica, magari alla vigilia di consultazioni elettorali, sarà essenziale capire quali saranno le responsabilità e quali i controlli di trasparenza sul governo. E parimenti sarà essenziale connettere le politiche di tutela interna alle strategie globali del Paese – sia nel campo dello sviluppo tecnologico, sia in quello dell’indipendenza dei meccanismi di sicurezza. Tutto questo non può rimanere semplice tema di una bega interna al governo, e concludersi magari con uno scambio di attribuzioni e dotazioni che dia ancora più potere al vertice di palazzo Chigi.