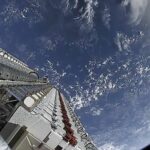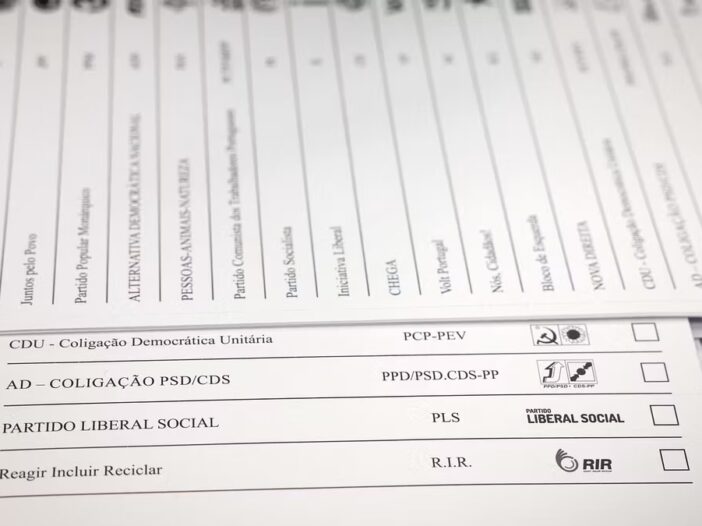
La sconfitta della sinistra portoghese non può non essere analizzata in un contesto europeo, che vede l’intera esperienza socialdemocratica, cioè la cultura politica più legata al patto sociale del welfare, quello fra capitale e lavoro, naufragare a tutte le latitudini: dalla sazia e soddisfatta Svezia a un Paese latino come il Portogallo, con una sinistra che sembra stia diventando una specie in estinzione. La politica internazionale è pura cronaca. Dinanzi a questa crisi bisogna avere un approccio più complessivo, in cui la nostra filosofia politica deve combinarsi con una robusta riflessione socioeconomica.
I dati della cronaca elettorale portoghese non lasciano spazio a sofismi: in meno di tre anni, quello che era sembrato un trionfo, un caso lusitano nel continente, si è rovesciato nel suo contrario. Lisbona si allinea alle capitali di Paesi sovvertiti da una destra ribellista e rancorosa, che succhia consensi alla base popolare della sinistra e mobilita il centro moderato in una guerra di accaparramento reazionaria. Solo nel 2022 i socialisti, guidati dall’attuale presidente del Consiglio europeo, António Costa, avevano raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi, dopo un periodo in cui avevano dato vita – mettendo da parte lunghe polemiche e contrasti che risalivano, in alcuni casi, alla mitica rivoluzione dei garofani del 1975 – a un’intesa con formazioni di una sinistra più radicale, la cosiddetta geringonça (“il marchingegno”), che prevedeva l’appoggio esterno dei comunisti e del Bloco de esquerda, e aveva garantito, fino a un certo punto, una tranquilla navigazione parlamentare. Un’esperienza che veniva indicata come la dimostrazione che “c’è vita su Marte”, che la sinistra europea poteva produrre modelli di governo della modernità, combinando competizione tecnologica e tutele sociali insieme con una visione comunitaria dell’economia. Già allora, però, si segnalava uno spostamento a destra dell’opposizione conservatrice, che cominciava con le sue prove generali di sovranismo.
Ma il miracolo portoghese è venuto omologandosi alla storia di una sinistra mediterranea rissosa e settaria: ognuno ha cercato di prevalere in visibilità e identità, e soprattutto si è allargato il buco nero della rappresentanza sociale. Una larga parte della popolazione, anche proprio per le riforme e lo sviluppo indotti dal governo socialista, cresceva in ambizioni e pretese. Le tutele erano non più conquiste ma attributi amministrativi, mentre si faceva largo quel senso di inquietudine che sta contaminando le fasce popolari in Europa, dove l’angoscia di difendere quello che si ha prevale sulla rabbia per conquistare spazi di democrazia e diritti. Il nemico diventa chi si ha alle spalle e non chi ci sta sulla testa.
Lungo questo piano inclinato di un sovversivismo dei ceti medi, alimentato da accorte campagne di contatti digitali estremamente capillari, si è rotto lo specchio del “socialismo del fado”, come si chiamava l’esperimento di Costa. I voti popolari sono rifluiti verso la nuova destra sovranista Chega, che ha cominciato a tallonare, con oltre il 22% dei voti, il partito di centrodestra, arrivato a superare il 32%. Mentre le aree professionali e produttive si rifugiavano in un individualistico disinteresse. Come al solito, governando saggiamente si perdevano i consensi tradizionali e non si guadagnavano quelli moderati. Una “sindrome cilena”, che oggi si delinea alla luce della “talpa digitale”, che scavando nelle relazioni sociali ed economiche ha riclassificato comportamenti e linguaggi, lasciandoli orfani di ogni rappresentatività politica.
Si logora così l’ombrello socialdemocratico che, in tutta Europa, diventa il retaggio di un ormai melanconico passato. L’esperienza nordeuropea è sostituita da formazioni di nazionalismo economico. Francia e Italia, con intensità diversa, hanno chiaramente alle spalle la fase espansiva e sono o risicate testimonianze georeferenziate nei centri storici di alcune grandi città, oppure, come nel nostro Paese, eredità in logoramento di grandi dotazioni elettorali del passato. A Londra e a Madrid tengono banco due modelli diversi, ma segnati da un destino comune: assediati dal mondo, sono spinti a omologarsi sui temi della tutela degli autoctoni, oppure a fare occasionali incursioni nel campo dei diritti per segnare una differenza sempre più precaria.
Allora la lezione portoghese, per il suo repentino passaggio dalla vittoria alla sconfitta, deve essere il pretesto per aprire una riflessione. La domanda è: in una società computazionale, dove i modelli produttivi e le relazioni sociali atomizzano e separano i diritti dal potere, e dove il lavoro è sempre più gregario rispetto alla professionalità, la sinistra chi rappresenta? E ancora: la sinistra si propone come alternativa alla gestione amministrativa del governo – per fare che cosa?
Sono queste le domande che attraversano i diversi scacchieri elettorali e politici. Domande che interrogano figure sociali e interessi economici distinti e distanti dalla tradizione del secolo scorso: lavoro e intellettuali sono ormai funzionari dell’algoritmo, direbbe Umberto Galimberti. Ed è questo il punto alto dello scontro che dobbiamo aggredire, esattamente come scriveva un impaziente filosofo tedesco, nel 1847, in un saggio intitolato Miseria della filosofia: “La macchina esercita tale influenza nella divisione del lavoro, che quando nella fabbricazione di un prodotto qualsiasi si è trovato il mezzo di produrre a macchina qualche parte di esso, la sua fabbricazione si divide immediatamente in due gestioni indipendenti l’una dall’altra”. Indipendenti ma, dopo quasi due secoli, dovremmo avere capito che ciò avviene con una gerarchia di comando che vede il sapere prevalere sul lavoro vivo, e nel sapere la proprietà contrapporsi alla cooperazione del general intellect.
È in questo gorgo, che oggi chiamiamo automazione psicosensoriale mediante intelligenze artificiali, che dovremmo riformulare l’idea di una sinistra che congiunga radicalmente consenso popolare, per un cambiamento visibile, con opinioni e competenze professionali per una competizione globale. Con il vantaggio che davvero non abbiamo proprio nulla da perdere se non una mediocre nomenclatura di partito.