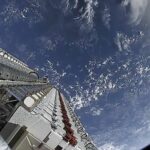Esiste ancora l’operaismo? Sì, a destra. Il consolidarsi di una cospicua base di consenso elettorale per le formazioni più estreme e intolleranti della destra sovranista, negli insediamenti di lavoratori del ciclo manifatturiero, è oggi il buco nero su cui dovrebbe riflettere la sinistra, invece di esorcizzarlo, come sta accadendo anche riguardo alla campagna referendaria del prossimo giugno. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Per rimanere solo ai più recenti, ci basti analizzare quanto è accaduto in Gran Bretagna e in Romania. Due realtà molto diverse per contesto sociopolitico, tipologie di consultazioni e sistemi elettorali. Ma proprio le differenze rendono assolutamente sorprendente l’unico tratto comune: l’affermazione di improbabili e del tutto disarmanti movimenti, caricaturalmente reazionari, guidati da personaggi improbabili, che hanno ricevuto consistenti consensi proprio nelle aree di più solida e radicata tradizione operaia.
Sia nelle amministrative inglesi, dove ha vinto a mani basse il partito di Farage, il promotore della Brexit, sia nelle elezioni politiche rumene dove ha trionfato la destra più estrema, nazionalista e filorussa, si è verificato un travaso di voti dalle formazioni della sinistra socialdemocratica direttamente ai candidati reazionari e razzisti. Un fenomeno non dissimile da quanto sta accadendo nelle piazze più rappresentative, dagli Stati Uniti di Trump, alla Germania dell’AfD, alla Francia di Le Pen e all’Italia meloniana.
I successi di questa destra sfrontata e sgangherata, priva di una classe dirigente plausibile, del tutto occasionale nelle sue strategie, hanno provocato micidiali boomerang, quali gli effetti sulla vita quotidiana della scelta antieuropea in Inghilterra, oppure il rigetto immediato per le guasconate sui dazi di Trump da parte dei mercati finanziari, per non parlare delle gaffe che diversi componenti del governo guidato da Fratelli d’Italia hanno collezionato a Roma. Eppure, nulla sembra scalfire la narrazione che vede i ceti disagiati cercare e trovare opportunità di riscatto nelle promesse del tutto inattendibili dei leader sovranisti.
In particolare, sono le moltitudini di operai, di addetti ai cicli manifatturieri, che spostano le proprie comunità – in qualsiasi ambiente o Paese comunque cementate da una qualche identità di classe, riconoscibile per stili di vita e insediamento territoriale – dal tradizionale campo di una sinistra politica e sociale a quello di una rancorosa e intollerante destra etnica.
Il voto inglese ci segnala un aspetto più specifico di questo operaismo di destra. In uno dei Paesi in cui è più forte la cultura del bipartitismo, si assiste a una crisi parallela dei gruppi dirigenti dei due partiti storici (conservatore e laburista), entrambi affondati per il loro carattere elitario e istituzionale. Diciamo, perché sono troppo sistema. Il voto sulla Brexit aveva già reso chiara questa rivolta anti-istituzionale, contro gli apparati e la nomenklatura. Nei collegi più marginali, dove la povertà del lavoro era più diffusa, una valanga di “no” contro l’Europa fece trionfare gli isolazionisti. E oggi non è certo servita la banale e inoppugnabile constatazione degli effetti negativi dello strappo da Bruxelles per mitigare il rancore anti-Londra. Proprio i ceti più disagiati sono stati colpiti dall’impennata dei prezzi, in alcuni casi addirittura da una penuria di generi di prima necessità. Eppure, la separazione dall’Europa era stata intesa come una punizione per i ceti amministrativi e globalisti, e come un modo per ridurre l’afflusso di mano d’opera immigrata, salvaguardando così il costo del proprio lavoro. Sembrerebbe una vendetta di classe quella che porta le aree più popolari – che in Inghilterra sono rimaste, anche nelle fasi di maggiore egemonia laburista, distanti dall’accesso alle sfere elitarie, ancora oggi riconoscibili per le scuole frequentate diverse da quelle dei comuni mortali – ad affidarsi ai peggiori esponenti di esperienze avventurose e quanto mai equivoche, e che discendono proprio da quei ceti privilegiati che si vorrebbero contestare.
In Romania, appare più secca la contrapposizione fra le città e la campagna. Le prime protese verso l’Europa, la seconda che ancora si appoggia alla nostalgia dell’assistenzialismo del vecchio regime, oggi recuperato e ibridato proprio dalla destra più estrema e antisocialista.
In Italia, abbiamo vissuto le prove generali di questa specie di sindrome di Stoccolma sociale negli gli anni del berlusconismo. Un miliardario molto discusso, un pregiudicato, che diventò il vettore di una liberazione dalle cupole intellettuali e gentilizie di una sinistra amministrativa.
La chiave per intendere l’operaismo di destra, che vede proprio le aristocrazie del lavoro subalterno in prima fila nel contrasto a ogni forma di progressismo culturale e sociale, è l’alleanza fra i secondi e i penultimi contro quella che appare la dittatura dei primi e degli ultimi. La paura di chi abbiamo alle spalle, in questa logica, prevale largamente sulla rabbia di chi si trova in basso. L’immigrazione e la concorrenza globale sono i nemici da condividere con il proprio padrone: la Cina, che insidia i fatturati delle aziende, gli immigrati che abbassano il costo del lavoro. Il collante che cementa queste due ragioni materiali è la frustrazione per essere esclusi dal sogno dell’emancipazione. Per quante conquiste sociali ci siano – dalla scuola alla sanità, alla mobilità e al turismo – le élite metropolitane progressiste sono sempre un passo in avanti: se hai la laurea, i loro figli hanno il master; se sei in ospedale, loro sono in clinica; se vai al mare loro sono già alle Maldive.
La destra populista ha colto questa rabbia dei penultimi ingabbiandola in una bolla comunicazionale, di cui la rete è stata la grande clava, che ha colpito inesorabilmente. Proprio la coerenza fra i linguaggi social e i contenuti sovranisti rimane oggi un buco nero che la sinistra non riesce ad attaccare, scomponendone gli elementi e riprogrammandone gli effetti.
I risultati in controtendenza di Canada e Australia, dove pure stava salendo la marea sovranista, replicando la stessa sindrome del rancore operaio, dimostrano che solo una contro-narrazione, che riesca a offrire un’opportunità di mobilitazione all’intera scala sociale, può riuscire a neutralizzare il vento populista.
L’operaismo di sinistra – quello originale degli anni Sessanta – colse con grande lucidità questa ragione. Misurandosi con la concretezza della prima automazione di fabbrica, mediante le esperienze dei “Quaderni rossi”, e grazie a una leva di straordinari sociologi della modernità che lavoravano sull’indotto olivettiano, comprese come l’inesorabile logica informatica poteva essere aggredita rovesciandone il senso: riprogrammarne la potenza per mutare il lavoro e non difenderlo. L’operaio che scambiava numeri e cedeva saperi alla macchina poteva tornare al centro della scena se contestava la composizione e i fini di quel processo tecnologico, non la sua progressione rispetto alla manualità. Fu una breve stagione, che oggi però potrebbe aiutarci a contendere alla destra la capacità di narrazione e di comunicazione con aree sociali destinate alla rottamazione assistenziale per chi vuole da loro solo i voti per comandare. Come scrive un seducente saggio, composto con il supporto di diverse intelligenze artificiali, intitolato Ipnocrazia (Tlon), che decifra la semantica di questi incantatori di serpenti, “Trump e Musk non sono figure di potere ma dispositivi narrativi (…). Non mirano a convincere ma a incantare”. Una china che sarebbe terribile volere imitare.
Proprio l’esperienza operaista degli anni Sessanta, invece, con il suo lucido sogno del controllo operaio nel punto più alto dello scontro, potrebbe suggerirci una via che faccia uscire il mondo del lavoro dalla trance: con le forme di automazione neurale della nostra vita, è indispensabile avere l’ambizione di ripensare l’intera scala gerarchica, alla luce di una condivisione di queste potenze tecnologiche e delle loro categorie, quali i dati e gli algoritmi, da sottrarre a una forma di proprietà privata, contrapponendosi a una destra che mobilita i poveri per difendere la proprietà dei ricchi.
A chi ci accuserà di fumosità e astrattezza (proprio un giorno dopo l’anniversario della nascita, il 5 maggio, di un filosofo che voleva cambiare il mondo) potremmo domandare: cosa abbiamo mai da perdere se non le nostre sconfitte?